Questa settimana, vuoi per la Pasqua vuoi per numerose altre sfortunate congiunture, in fumetteria non ho trovato niente di mio gradimento. Così sono partita nell’iniziativa che mi vede recuperare alcuni ghiotti e dispendiosi volumoni con storie che ho letto ma che non possiedo.
 E il primo non poteva che essere Marvels scritto da Kurt Busiek e meravigliosamente dipinto da Alex Ross. Perché? Beh, innanzitutto perché quest’opera incontra sia il mio amore per le narrazioni da punti di vista insoliti sia la mia sfrenata passione per pittori e illustratori nel fumetto. Secondariamente perché è un must. Terzo perché fa da trampolino per la mia ricerca del suo seguito, Marvels: Eye of the camera. E ovviamente non mi dispiacerebbe nemmeno recuperarmi Ruins.
E il primo non poteva che essere Marvels scritto da Kurt Busiek e meravigliosamente dipinto da Alex Ross. Perché? Beh, innanzitutto perché quest’opera incontra sia il mio amore per le narrazioni da punti di vista insoliti sia la mia sfrenata passione per pittori e illustratori nel fumetto. Secondariamente perché è un must. Terzo perché fa da trampolino per la mia ricerca del suo seguito, Marvels: Eye of the camera. E ovviamente non mi dispiacerebbe nemmeno recuperarmi Ruins.
Ma non divaghiamo.
Come molti di voi sapranno, Marvels narra la storia delle “meraviglie” dalla Seconda Guerra Mondiale alla comparsa pubblica dei mutanti, ma dal punto di vista di un uomo comune, il giornalista Phil Sheldon.
Lo spunto non è nuovo: il punto di vista dell’uomo comune, il taglio giornalistico, sono utilizzatissimi da storielle autoconclusive come quelle che di recente abbiamo visto su Wolverine a story-arc più lunghi e complessi come la recente storia di Jenkins su Civil War Frontline. E’ un punto di vista interessante, perché consente di giocare attraverso una doppia lente, un doppio straniamento, un po’ come quando Tolkien ci mostra Gandalf attraverso gli occhi del “normale” Bilbo (che a sua volta ai nostri occhi tanto normale non è). La cosa è spiegata egregiamente dagli autori stessi nella prima proposta: gli eroi Marvel vengono presentati sin dall’inizio come eroi fragili, con tutte le debolezze e i vizi che tutti conosciamo, ma che cosa penserebbe di queste caratteristiche l’uomo medio del Marvel Universe, che spera di essere salvato dalle Meraviglie?
Il numero si apre, simbolicamente, con la nascita della prima Torcia Umana (Marvel Comics #1: ne abbiamo parlato di recente per Vendicatori / Invasori) e l’entrata in scena di Namor (Marvel Mystery Comics #4). Il punto di vista della Torcia, che parla in prima persona della propria nascita, è forse l’unico punto di vista interno alle “meraviglie” e ci mostra l’inizio della golden age con un tono introspettivo e malinconico: rispetto alla prima sinossi, dato che è stata poi eliminata l’idea dell’intervista alla torcia mi sarebbe piaciuto che in questa prima parte venisse integrato lo spunto di veder parlare l’androide con frasi fatte, un essere che sta ancora imparando ad essere umano. In generale, se si può fare un appunto all’impianto narrativo dell’opera, è proprio questa prima parte ad essere slegata dal resto, un modulo sopravvissuto all’impianto originale ma rimasto orfano di senso.
 Rinnovata potenza ha acquisito invece, attraverso le revisioni, la storia di Namor. Al posto di ignorare o ret-conizzare il punto più problematico del personaggio, ovvero i suoi continui cambi di schieramento, Ross e Busiek vi si concentrano, facendone il punto focale della vicenda. Se il primo smarrimento dell’uomo comune di fronte alle meraviglie era dovuto alla paura della novità (lo show di presentazione della torcia), il secondo smarrimento è proprio per l’apparente incostanza di colui che veniva ritenuto un eroe: Namor, il Namor che tutti amiamo quando non si imborghesisce (cit), ci regala alcune tra le scene più belle dell’albo, e non mi riferisco solo a quelle in cui appare nudo.
Rinnovata potenza ha acquisito invece, attraverso le revisioni, la storia di Namor. Al posto di ignorare o ret-conizzare il punto più problematico del personaggio, ovvero i suoi continui cambi di schieramento, Ross e Busiek vi si concentrano, facendone il punto focale della vicenda. Se il primo smarrimento dell’uomo comune di fronte alle meraviglie era dovuto alla paura della novità (lo show di presentazione della torcia), il secondo smarrimento è proprio per l’apparente incostanza di colui che veniva ritenuto un eroe: Namor, il Namor che tutti amiamo quando non si imborghesisce (cit), ci regala alcune tra le scene più belle dell’albo, e non mi riferisco solo a quelle in cui appare nudo.
La seconda parte è, se così possiamo definirla, la parte in cui il senso di stupore e di meraviglia viene definitivamente destabilizzato: le meraviglie divengono normali, strappando all’uomo comune la sua posizione e minacciando la sopravvivenza della stessa razza umana. In poche parole, i mutanti sono tra noi.
Geniale e azzeccatissimo lo spunto di ribaltare comletamente la prospettiva di fronte ai mutanti rispetto a quella tenuta di fronte ai supereroi “classici” (che volendo si potrebbero definire “mutati”): i mutanti non scelgono di essere meraviglie, e potenzialmente non lo sono nemmeno. Possono essere mostruosi, inquietanti, grotteschi, ma soprattutto non scelgono di essere quello che sono e non vengono baciati da una qualche benevola provvidenza che li trasforma nei paladini della giustizia. I mutanti sono scherzi di natura e, soprattutto, sono il futuro dell’umanità. E questo, ovviamente, al resto dell’umanità non va particolarmente a genio.
Rispetto al primo concept, con Sheldon che va a cercare i mutanti e la bambina che si suicida, la versione definitiva ha decisamente acquisito maggiore pathos: gli X-men rimangono sullo sfondo, delle figure mascherate che vengono aggredite dalla folla, e protagonisti della sezione sono i mutanti “normali”, la bambina, la popolazione di Genosha sterminata dalle sentinelle. Il tutto sullo sfondo di un lieto evento (ehi! ma la timeline è davvero così?) la cui futilità quasi metafumettistica esplode in un momento davvero amaro.
 A questo punto, risulta più che normale che la terza sezione alzi gli occhi al cielo. E nell’universo Marvel quando si alza gli occhi il meglio che può capitare è beccarsi una cacchetta del Silver Surfer sulla faccia. Non a caso, in pieni anni ’60, è proprio il Divoratore di Mondi a fare la sua comparsa nell’obiettivo del giornalista. E trovo che sia proprio in questo caso che l’espediente delle “meraviglie”, la doppia magnificazione degli eroi raccontati a noi gente comune dagli occhi di una persona comune, supera se stesso. Ancora una volta l’umanità assiste impotente ad uno scontro muto, prima tra i Fantastici Quattro e l’imbattibile Silver Surfer e poi tra quella stessa meraviglia cosmica e qualcosa di ancora più grande. Galactus non è mai stato così potente, così magnifico, così terrificante. Ma risolvere la narrazione così sarebbe banale, e viene introdotto un nuovo punto di svolta: la diffidenza nei confronti degli eroi, la distorsione mediatica che diviene quasi transfert psicanalitico, negazione che cose come quelle – in cui l’umanità deve osservare impaziente attendendo un imprevisto stravolgimento di eventi – non possano accadere. Le meraviglie, per quanto perfette e potenti, non possono sempre salvarci.
A questo punto, risulta più che normale che la terza sezione alzi gli occhi al cielo. E nell’universo Marvel quando si alza gli occhi il meglio che può capitare è beccarsi una cacchetta del Silver Surfer sulla faccia. Non a caso, in pieni anni ’60, è proprio il Divoratore di Mondi a fare la sua comparsa nell’obiettivo del giornalista. E trovo che sia proprio in questo caso che l’espediente delle “meraviglie”, la doppia magnificazione degli eroi raccontati a noi gente comune dagli occhi di una persona comune, supera se stesso. Ancora una volta l’umanità assiste impotente ad uno scontro muto, prima tra i Fantastici Quattro e l’imbattibile Silver Surfer e poi tra quella stessa meraviglia cosmica e qualcosa di ancora più grande. Galactus non è mai stato così potente, così magnifico, così terrificante. Ma risolvere la narrazione così sarebbe banale, e viene introdotto un nuovo punto di svolta: la diffidenza nei confronti degli eroi, la distorsione mediatica che diviene quasi transfert psicanalitico, negazione che cose come quelle – in cui l’umanità deve osservare impaziente attendendo un imprevisto stravolgimento di eventi – non possano accadere. Le meraviglie, per quanto perfette e potenti, non possono sempre salvarci.
Anzi.
Le meraviglie non sono affatto perfette, e a volte non riescono a salvare nemmeno loro stesse. L’ultimo, amaro capitolo, spetta all’uomo ragno, con la morte di Gwen Stacy. Facile, scontato ma comunque d’effetto affidare la conclusione amara a quella che molti definirebbero la storia più toccante del Marvel Universe. Facile, scontato ma comunque d’effetto far passare la disillusione di Sheldon attraverso un debole momento di illusione di fronte al candore di Gwen. Facile, scontato ma d’obbligo il modo in cui viene trattata la verità sulla morte di Gwen, la colpa del ragno nell’avvenimento, la caduta dell’eroe. E’ una conclusione amara, ma non potevano essercene di migliori: è l’evoluzione che ha portato gli eroi Marvel a essere quello che sono ora (o almeno, quello che dovrebbero essere).
Talmente tanti i cameo e le citazioni che è impossibile elencarli tutti: Betty Dean nello story-arc di Namor, un giovane Nick Fury, lo stesso Peter Parker nella redazione del Bugle, un giovane Danny Ketch, futuro Ghost Rider, alla fine della storia, l’onnipresente dipinto di Hopper (una discreta collezione qui, qui e qui, s volete).
Insomma, un must have.

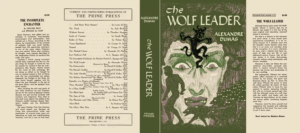


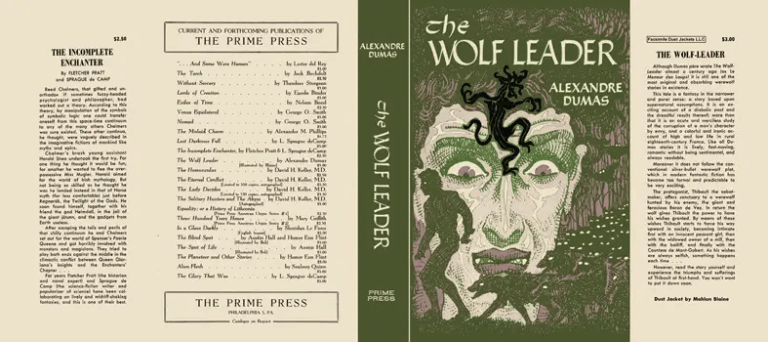


No Comments