
Arte, calligrafia e judo passaggi oltre il blu – Marco Dotti
Per sei anni, dal 1948 al 1954, Yves Klein condusse la vita di un infaticabile viaggiatore. Dopo avere visitato l’Italia in autostop, percorso l’Irlanda a cavallo, prestato per undici mesi servizio militare in Germania, insegnato arti marziali a Madrid e appreso la tecnica della doratura da un artigiano londinese, il 22 agosto del 1952 Klein trovò spazio su un mezzanino di terza classe e da Marsiglia si imbarcò verso il Giappone. Vi rimase due anni, con l’intenzione di approfondire la conoscenza della lingua e degli usi, studiati all’Ecole Nationale des Langues Orientales di Nizza e, soprattutto, di perfezionare la pratica del judo. Klein amava viaggiare più come «nomade esistenziale» che come un artista in cerca di nuovi orizzonti; e, al tempo stesso, non amava i confini, né quelli geografici, tanto meno – come avrà modo di scrivere nel testo preliminare all’esposizione di Le Vide (tradotto in questa pagina per la prima volta) – quelli che circoscrivono il campo della visione. Nei cinque diari redatti nel corso dei suoi continui spostamenti non mancano annotazioni e spunti su quelli che, negli anni successivi alla consacrazione internazionale, diverranno termini chiave della sua carriera artistica: l’assenza di punti fuga, l’energia e la sensibilità.
I relativi problemi che si incontrano nella consultazione degli scritti di Klein, il loro carattere frammentario, lo stile nervoso, la loro dispersione in fondi spesso inaccessibili, insieme alla sua immagine atemporale e mitica, hanno reso complicato ricostruire il periodo relativo alla formazione dell’artista. Come osserva Nicolas Charlet, in un lavoro documentatissimo che ha per titolo Les écrits d’Yves Klein (Luna Park – Transédition, pp. 362, euro 32), è però proprio fra quelle carte, nella direzione contorta di quei viaggi, nella disciplina ferrea del judo, nel «ventre cavo» di quel mito, che l’esperienza iniziale di Klein prende forma e quella successiva si conforma. Sulla via della lentezza. Atleta, esteta, viaggiatore, Klein fu anche scrittore: a un ritmo incessante, infatti, scrisse fino al momento della morte, che arrivò il 6 giugno del 1962, quando aveva solo trentaquattro anni. E benché, osserva Charlet, i suoi scritti non abbiano valore letterario, così come le sue imprese atletiche non sempre travalicano l’ambiente sportivo, è proprio attraverso la mediazione della scrittura e del judo che egli si «consacrò» artista. Appassionato di sport, fin dall’adolescenza, dopo aver abbandonato la savate, boxe francese considerata troppo violenta, Klein si era dedicato allo studio della «via della lentezza», in compagnia di Armand Fernandez (Arman) e del poeta Claude Pascal. Tra loro si era stabilito una sorta di patto implicito sull’intenzione di «imparare il judo non come sport o tecnica di combattimento, ma per penetrare nello spirito bushido e quindi nello zen». I tre, che si riunivano in una cantina interamente dipinta di blu, leggevano i libri di Max Heindel – il fondatore del movimento Rosacrociano – ma studiavano anche le lettere e il diario di Eugène Delacroix, praticavano il digiuno e la meditazione e si sottoponevano a un continuo esercizio di scrittura. «Allora – si legge in un passo del diario – disegnavo, ma poco, e il fatto che mio padre e mia madre fossero pittori mi infastidiva e allontanava dalla pittura. Comunque, fu grazie a loro che ero tenuto al corrente delle idee più estreme dell’avanguardia pittorica. Forse a causa di questo, cercavo inconsciamente di andare sempre più lontano». Questo «andare sempre più lontano» per Klein si sarebbe concretizzato in una fusione esplicita e visibile fra gesto e arte, fra l’automatismo marziale e l’immediatezza del gesto calligrafico, di cui la ricerca del vuoto rappresentò una sorta di contropartita invisibile. «Ciò che mi appassiona nel judo – scriveva – è il movimento. La linea del movimento che è sempre astratta». Questa linea di movimento sarà poi uno dei temi cardine di un’opera fra le più oscure e sottovalutate di Klein, Les Fondements du judo, che solo ora comincia a essere presa nella dovuta considerazione, sull’onda delle ricerche di Nicolas Charlet, a cui si deve anche il riordino degli «Archives Yves Klein», e in coincidenza con l’importante mostra, anche documentaria, del Centre Pompidou (inaugurata il 5 ottobre e aperta fino al 5 febbraio). Nel 1954, presso l’editore Grasset (l’editore di Cocteau, Radiguet, Malraux), Klein pubblicò infatti un volume che per molto tempo gli specialisti hanno rifiutato di considerare altro che una semplice parentesi nella formazione dell’artista. A priva vista, si tratta di un libro soltanto tecnico, composto da fotogrammi e brevi descrizioni, dedicato all’estetica e, come recita il titolo, a Les Fondements du judo (le edizioni Dilecta lo hanno da poco ristampato, affiancando all’originale premessa di Ichiro Abe una nota di Jean-Luc Rogé, pp. 204, euro 19). Eppure, proprio nei Fondements du judo Klein mette all’opera una prima strategia di sovrapposizioni, distanziamenti e paradossi. Le immagini non sono semplici fotografie, ma fotogrammi tagliati da una serie di cortometraggi, che illustrano «l’estetica del judo» per mezzo di figure, i kata. Attraverso i «fotogrammi statici» l’immagine in movimento dovrebbe «imprimersi nella memoria» e produrre, dopo una serie infinita di osservazioni e ripetizioni, quel «gesto automatico» e disteso che unisce «judo, arte e calligrafia». L’istante tra il battere e il levare Non è chiaro il motivo per cui Klein scelse di tagliare le pellicole, utilizzandone i fotogrammi, anziché servirsi di normali fotografie. È possibile che, con questa operazione, intendesse richiamare implicitamente l’elemento sospeso, l’istante fra il battere e il levare, la levitazione dell’atleta nell’aria che è la meta di una «figura impossibile», il kata detto «degli uccelli», che per lui costituiva forse un conto troppo aperto. Solo nell’autunno del 1960, sovrapponendo la propria immagine a uno sfondo di Harry Shunk, che ritraeva una strada di Fontenay-aux-Roses, quartiere alla periferia parigina, Klein realizzò quella che ancora oggi rimane una delle sue immagini più emblematiche e, al contempo, una delle sue imprese più ardite. Lanciandosi nel vuoto, Klein raggiunse la «sesta figura» (itsutsu no kata) descritta nel suo libro, ma accessibile solo dal sesto dan. Secondo i testimoni, «fece il suo salto come si recita una poesia». Nel momento in cui decise di saltare nel vuoto, Klein scelse dieci assistenti, pronti ad attutirne la caduta e ad assisterlo durante la complessa preparazione che lo precede. Da circa tre anni non praticava ufficialmente il judo, e alla fine del salto consegnò il proprio kimono in segno di congedo. «L’uomo nello spazio! Il pittore dello spazio si getta nel vuoto!», titolò Dimanche, «giornale di un solo giorno», scritto, composto, stampato e infine distribuito nelle edicole di Parigi dallo stesso Klein in settemila copie, riprendendo il fotomontaggio. Attraverso le arti marziali, Klein maturò la convinzione, che si sarebbe rivelata determinante nella serie delle Antropometrie, che «il corpo umano è uno spazio», pervaso da una sorta di «energia poetica» fuori-quadro. Il quadro – scrisse nel testo che accompagnava l’esposizione Le Vide, presso lo spazio di Iris Clert il 28 aprile del 1958 – è «energia poetica concentrata», laddove occorre ormai scioglierla in una «materia immateriale, impalpabile, non concentrata», libera nella sua forma «energetica». Un «gesto d’aria», rappresentato proprio dalle pareti completamente bianche della galleria Clert, che avrebbe dovuto essere invasa, di riflesso, dall’obelisco di Place de la Concorde illuminato di blu, come naturale conseguenza rispetto alle Propositions monochromes mostrate, due anni prima, nella galleria di Colette Allendy (moglie di René, mentore di Antonin Artaud) e alle tracce dell’Epoca blu portate a Milano, nello spazio di Guido Le Noci. «Il judo», scriveva Klein, «è arte, arte con lo stesso valore della grande musica», ponendo in tal modo una distinzione che sarebbe stata fondamentale per tutto il seguito della sua attività: la ripetizione non è la riproduzione. Come la musica possiede una sorta di proprietà allografica, «deve essere ricreata ogni volta», e ogni volta l’estrema libertà del gesto si deve coniugare col suo automatismo, così l’apprendimento mnemonico dei kata, le forme, studiate e ripetute fino allo sfinimento devono infine sciogliersi nella naturalezza e nella dimenticanza, come il corpo e il colore devono liberarsi nell’immateriale. Corpo, colore, immateriale: è proprio attorno a questi concetti che, a distanza di tredici anni dalla precedente esposizione, la mostra del Centre Pompidou si consacra a una nuova, importante rassegna delle opere e del pensiero di Yves Klein. Strutturata secondo un percorso che gli stessi curatori non esitano a definire «iniziatico», la mostra presenta centoventi fra dipinti e sculture, oltre a numerosi film, quaderni, fotografie e appunti dell’artista. Costruita attraverso tre fasi della ricerca di Klein, scandite da altrettante parole-chiave – «impregnazione, illuminazione della materia e incarnazione», connesse al blu, all’oro e al rosa, colori che l’artista nizzardo riteneva complementari al proprio lavoro – l’esposizione permette di confrontarsi con l’ambivalenza, non solo con la profondità, del gesto-assente di Klein. Una nutrita serie di pubblicazioni Tra i molti eventi organizzati in concomitanza con la mostra, il 15 e il 19 ottobre Philippe Arrii-Blachette dirigerà i quaranta minuti (venti su un suono sospeso, venti di assoluto silenzio) della Symphonie Monoton-Silence scritta dall’artista, alla cui esecuzione parteciperanno un centinaio fra musicisti e coristi. Escono intanto, insieme al catalogo della mostra curato da Camille Morineau, un cd audio con la conferenza tenuta da Yves Klein alla Sorbona il 3 giugno 1959 (Editions Dilecta) e i lavori di Denys Riout, Yves Klein. L’aventure monochrome e La peinture monochrome. Histoire et archéologie d’un genre, entrambi editi da Gallimard. Preziosa, inoltre, la testimonianza del critico e poeta Alain Jouffroy, amico personale di Klein, che in Manifeste pour Yves Klein (ed. Virgile) ripercorre gli anni della formazione dell’artista, soffermandosi sulla sua profonda conoscenza della cultura Giapponese e sui risvolti «anche politici» di un’utopia rappresentata dalle «visioni dell’epoca blu». L’opera di Klein, come la mostra documenta, è multiforme e spazia dalla ricerca sul raddoppio fotografico, alle performance video, fino alla progettazione utopica di spazi urbani immateriali. Al tutto si aggiungono appunti e quaderni, progetti e fotografie di scena, che rendono un po’ più umana questa figura inevitabilmente associata ai monocromi, alle antropometrie, all’International Klein Blue, ma altrettanto inevitabilmente protesa verso un continuo salto nel vuoto.
Il colore è sensibilità divenuta materia – Yves Klein
Per quanto mi riguarda, l’arte di dipingere consiste nel restituire la libertà allo stato primordiale della materia. Un dipinto ordinario, come si capisce dalla sua materia generale, è per me come la finestra di una prigione, le cui linee, i contorni, le forme e la composizione sono determinati dalle sbarre. Per me, le linee concretizzano la nostra condizione mortale, la nostra vita affettiva, il nostro raziocinio, fino alla nostra spiritualità. Sono i nostri limiti psicologici, il nostro passato storico, la nostra educazione, il nostro scheletro. Sono le nostre debolezze e i nostri desideri, le nostre facoltà e i nostri artifici. Al contrario, il colore è a misura naturale e umana, si impregna nella sensibilità cosmica. La sensibilità di un pittore non è ingombra di angoli e recessi misteriosi. Contrariamente a ciò che la linea tende a farci credere, essa è come l’umidità nell’aria. Il colore è sensibilità divenuta materia, materia al suo stadio primordiale. Non posso più approvare un quadro «leggibile», i miei occhi sono fatti non per leggere un quadro, ma per vederlo. La pittura è colore e Van Gogh scriveva: «Voglio essere liberato non so da quale prigione». Credo soffrisse inconsciamente del fatto di vedere il colore tagliato dalla linea. Solo i colori abitano lo spazio, mentre la linea non fa che viaggiarci attraverso, percorrendolo in lungo e in largo. La linea attraversa l’infinito, mentre il colore è. Attraverso il colore provo una totale identificazione con lo spazio: sono realmente libero. Durante la mia seconda esposizione parigina, presso Colette Allendy, nel 1956, ho mostrato una scelta di Propositions di colori e formati diversi. Quello che mi aspettavo dal pubblico era quel «Minuto di verità» di cui parlava Pierre Restany nel suo testo. Prendendomi la libertà di fare tabula rasa di tutta quella vernice di impurità esteriore, cercando di raggiungere quel grado di contemplazione dove il colore diventa pura e piena sensibilità. Sfortunatamente, nel corso delle manifestazioni che per l’occasione ebbero luogo, accadde che molti degli spettatori fossero schiavi del proprio modo di vedere abituale, mostrandosi più sensibili alle relazioni di queste Propositions fra loro, ricreandosi gli elementi decorativi e architetturali di un disegno a più colori. Questo fatto mi invitò ad andare oltre nelle mie ricerche e a fare, nel gennaio del 1957, questa volta alla Galleria Apollinaire di Milano, una mostra dedicata a ciò che mi ero azzardato a definire il mio «Periodo blu» (è vero che da più di un anno mi ero consacrato alla ricerca dell’espressione più perfetta del blu). La mostra presentava undici quadri di un ultramarino scuro, tutti rigorosamente identici nel colore, valore, proporzione e grandezza. Le appassionate controversie che ne nacquero, e l’emozione profonda che la mostra provocò tra le persone di buona volontà, pronte a sottrarsi alla sclerosi delle vecchie concezioni e delle regole consolidate, attirarono l’attenzione sull’importanza del fenomeno. Malgrado tutti gli errori, le ingenuità e le utopie in cui vivo, sono felice di essere alla ricerca di un problema di così grande attualità. Ci serve – e non è un’esagerazione – pensare che viviamo nell’era atomica, in cui tutto ciò che è materiale e fisico può sparire dall’oggi al domani per lasciare il posto a tutto ciò che di più astratto possiamo immaginare. Credo che per il pittore esista una materia sensibile e colorata che è intangibile. Considero dunque che il colore stesso, nel suo aspetto fisico, arrivi a limitare e imbrigliare il mio sforzo verso la creazione di stati artistici sensibili. Per raggiungere quell’«indefinibile» di Delacroix che è l’essenza stessa della pittura, mi sono dedicato alla «specializzazione» dello spazio, che è la mia ultima maniera di trattare il colore. Non si tratta più di vedere il colore, ma di «percepirlo». In questi ultimi tempi, il lavoro del colore mi ha condotto, mio malgrado, a ricercare la realizzazione della materia con un sostegno (dell’osservatore – del traduttore) e ho deciso di porre fine al conflitto. Adesso, i miei dipinti sono invisibili e sono questi che vorrei mostrare, nella mia prossima esposizione parigina presso Iris Clert, in un modo chiaro e positivo. (traduzione di M. D.)





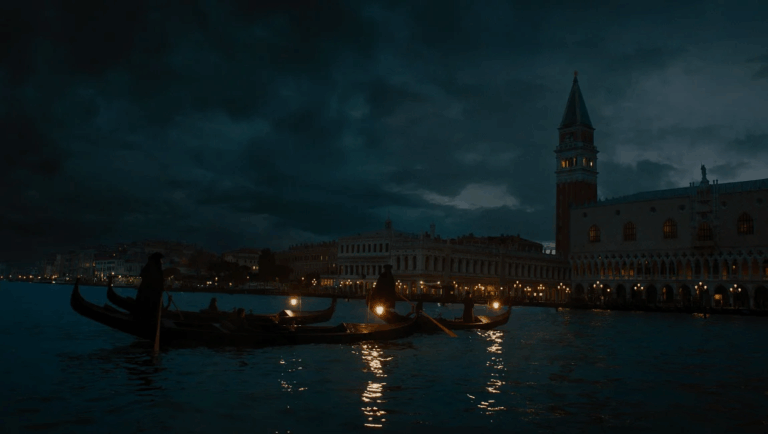

No Comments