
Dal Manifesto di oggi.
A caccia di storie con Tiananmen alle spalle – Silvia Calamandrei
Dire che «per la prima volta i cinesi raccontano i cinesi» – come annuncia il sottotitolo inserito dalla Einaudi (Stile libero) sulla copertina del libro di Sang Ye titolato China Candid – significa non soltanto fare torto al lettore ma soprattutto a un popolo che si racconta da secoli e che da noi si vorrebbe ricondurre a formule troppo semplici. Tuttavia, la raccolta di storie orali narrate da cinesi ordinari e messe insieme da Sang Ye (pp. 414, euro 15,80, traduzione di Gaia Cenciarelli, Giuseppe Mainolfi e Paola Ghigo, edizione italiana a cura di Mita Masci) è di godibile lettura e aggiunge qualche tassello alla nostra conoscenza del paese che sta in cima alla curiosità mediatica, tanto che i libri di Federico Rampini vanno a ruba e gli editori si affrettano a mettere sul mercato nuovi titoli. Tirarono bene, peraltro, anche i tanti reportage dell’epoca della Rivoluzione culturale, per non parlare della circolazione dei libretti rossi in Europa: era l’epoca in cui la Cina parlava il linguaggio del marxismo leninismo, condito di formule folgoranti come «abbattere il quartier generale», e la sua alterità sembrava promettere l’inverarsi delle nostre utopie. Ora che il suo modello di sviluppo è più simile al nostro e che tanto i singoli quanto i loro linguaggi presentano grandi differenze tra loro, quel paese ci appare paradossalmente più distante e lo scarto fa emergere la sua complessità dettando nuove interpretazioni capaci di leggere la sua irresistibile ascesa sulla scena globale, con tutti i tentativi elaborati per arrivare a nuove quadrature del cerchio. Quanto a Sang Ye, con il suo libro non pretende di elargirci una lettura della Cina ridotta in pillole per rendercela più vicina, perché anzi quelli che ci consegna sono tanti ritratti frammentati della «società civile» cinese, ognuno colto in presa diretta. Ed è forse questa la novità maggiore: il fatto che in Cina si dia una società civile, non tutta riassorbita dalla politica e dal suo linguaggio come appariva negli anni del maoismo. Un concetto controverso. Introducendo il libretto di Wang Hui titolato Il nuovo ordine cinese – appena tradotto per la manifestolibri (pp. 192, euro 18) – Edoarda Masi fa le pulci al concetto di società civile che l’intellettuale cinese utilizza connotandolo positivamente, e gli ricorda la divisione in classi; ma c’è da dire che forse i cinesi ora respirano di sollievo nel sentirsi rientrare nell’indistinto magmatico della società civile dopo essere stati ingessati in una classificazione rigida che assegnava ciascuno, ereditariamente, alla sua origine di classe. Uno spettro di problemi, questo, cui fa cenno Sang Ye in un passaggio della sua introduzione nel quale si lamenta dei treni superaffollati e si chiede cosa faccia «tutta quella gente in giro per il paese, a intasare il sistema dei trasporti»; ma poi torna sulle sue considerazioni, si corregge e plaude alla libertà di circolazione, prima interdetta. Dei disagi si consola considerando come, finalmente, persino ai figli dei proprietari terrieri, prima soggetti a una sorveglianza costante, sia consentito «uscire dalla – e viaggiare in – Cina». Ma andando avanti nelle sue riflessioni si rende conto che le persone alle quali si riferisce sono probabilmente non i figli bensì i nipoti di quei proprietari terrieri, ossia la prima generazione a godere della possibilità di muoversi liberamente. Proprio sulla questione relativa alla rigida divisione in classi interviene, tra gli intervistati nel libro di Sang Ye, il «non dissidente», spiegando di aver ottenuto la classificazione della famiglia di origine come facente parte dei «contadini medi», grazie alla sua appartenenza al partito: «Sapevano che sarebbe stato inaccettabile classificare come proprietarie terriere le famiglie i cui figli lavoravano per il partito e Pechino, giacché questi avrebbero finito per essere considerati nemici di classe». Ed esprime pure i suoi dubbi sull’aver liquidato come latifondisti tanti che possedevano pochi mu, lavoravano la terra e non avevano mai visto l’acqua corrente. È dunque una indagine di tipo antropologico quella che Sang Ye prosegue con China Candid, inquadrando la gente ordinaria attraverso la restituzione di storie orali, secondo il modello dell’indagine di Studs Terkel sull’America della Grande Depressione. Dopo avere realizzato negli anni ’80 un centinaio di interviste insieme alla scrittrice Zhang Xinxin, e averle raccolte sotto il titolo Beijingren (Homo pekinensis) per pubblicarle nella Cina ottimistica dell’apertura e delle riforme, prima di Tiananmen, stavolta Sang Ye ha fatto parlare circa venticinque cinesi incontrati in giro per il paese e ha pubblicato a Hong Kong (1999) e negli Stati Uniti (2006) non avendo trovato un editore disponibile nella Repubblica popolare cinese. Rispetto al testo precedente, di cui era già stata presentata una scelta in Italia nel 1990 per gli Editori Riuniti, i narratori anonimi risultano più a loro agio e non è intervenuta alcuna censura. I venti anni trascorsi ci consegnano, dunque, una serie di autoritratti di persone comuni inserite in una società più atomizzata e disgregata, con meno punti di riferimento obbligati, con meno controlli ma anche minori reti di sicurezza. C’è l’imprenditore di successo che spiega come arricchirsi e c’è il contadino inurbato, classico esemplare di quella massa di migranti che vivono ai margini dei grandi centri urbani, al limite della sopravvivenza, e costituiscono il mercato delle braccia su cui prospera la speculazione edilizia. E c’è l’esponente dei mangliu, le centinaia di milioni di cinesi senza fissa dimora, una sorta di esercito salariale di riserva, che si consola pensando come anche Mao, quando arrivò a Pechino negli anni ’20 e trovò lavoro come bibliotecario, fosse un mangliu e venisse trattato come un bifolco. Nella intervista che lo ha per protagonista egli parla di un nuovo avvento di Mao a riscatto dei miserabili: i versi dell’inno maoista Il sole rosso sono già stati modificati per preannunciare la comparsa di Mao tra i mangliu. Compaiono, accanto a lui fra queste pagine, un membro del partito e un sindacalista che tuonano contro le riforme e la degenerazione capitalistica del paese, rimpiangendo un passato in cui la corruzione era minore: sono figure appartenenti alla vecchia generazione, che non capiscono più i propri figli quando si mettono a fare affari. E compaiono personaggi che danno vita a nuove forme di solidarietà e di reti associative, come i fondatori di un orfanotrofio privato e i genitori di bambini rapiti e messi in vendita. C’è l’esperta di contraffazione e c’è l’atleta che ha partecipato alle Olimpiadi e racconta le pratiche di doping. C’è persino il boia che descrive nei dettagli le esecuzioni o – figura più comune – l’insegnante che si arrabatta a integrare il misero stipendio organizzando corsi privati: una voce, tra le altre, di donne, alcune delle quali per guadagnare qualche soldo in modo rapido ricorrono alla prostituzione. Di certo, tra i personaggi più curiosi ci sono l’avvistatore di Ufo che si prepara al contatto con gli extraterrestri e il giovane hacker impegnato a prendersela con la proprietà intellettuale sostenendo che il codice binario è stato inventato dai cinesi con la teoria dello yin e dello yang. Il curatore dell’edizione americana di queste interviste – un sinologo australiano di nome Geremie Barmé, tra i più acuti osservatori della Cina in transizione, da lui documentata con preziose antologie di scrittori – scrive nella postfazione che attraverso le interviste, realizzate nel corso di anni, Sang Ye ci fornisce una storia alternativa, o meglio una sorta di biografia della Repubblica popolare cinese, dalla sua fondazione nel 1949 al crollo del maoismo e al periodo delle riforme. Come cacciatore di memorie, Sang Ye si serve di conversazioni ripetute più volte, che poi rielabora eliminando il proprio ruolo, anche se sono le sue domande mirate a guidare il filo logico del ricordo e della testimonianza. Quello che ci presenta è dunque il resoconto letterario di un intellettuale raffinato che è al tempo stesso un profondo conoscitore del contesto cinese: dalla sua esperienza ci viene la riorganizzazione di un materiale orale al quale egli aggiunge una impronta stilistica originale e inconfondibile. Voci mediate e toni perduti. Molto dell’immediatezza intrinseca alla oralità – ammette Sang Ye – va smarrita; e per parte sua Geremie Barmé sottolinea come nella versione inglese si sia perduto molto di più: «Gli originali sono freschi e potenti come può esserlo solo una lingua di rado pubblicata nella Cina continentale. I soggetti delle interviste non parlano la piatta neolingua dei media cinesi ufficiali, né ostentano gli atteggiamenti verbali fintamente disinvolti dell’hip-grunge urbano o della chick-lit, di cui spesso i media internazionali si servono per descrivere l’avanguardia della Cina contemporanea». Barmé, inoltre, dà conto accuratamente del suo lavoro editoriale e dello sforzo per rendere al meglio, insieme a Miriam Lang, la polifonia dell’originale, aggiungendo note a pie’ di pagina per esplicitare riferimenti non familiari al lettore occidentale. Ma nella versione italiana, purtroppo, la cura non è stata altrettanto meticolosa e la traduzione dall’inglese è stata affidata a tre mani diverse accomunate dalla scarsa conoscenza della realtà cinese e della bibliografia al riguardo: si va dalla confusione tra città e province della Cina, per cui si dice «Vengo da Guandong» che equivale a dire «da Lazio» o «da Baviera», a note che non danno alcun conto delle edizioni italiane e addirittura trasformano il maestro del Re dei bambini di Acheng in una maestra. Dato, poi, che i traduttori dall’inglese non conoscono il francese, «amateur» viene tradotto come «devoto». Questa sciatteria, anche stilistica, non può che spiacere: sarà stata dettata dalla fretta di sfornare un altro bestseller sulla Cina? Dopo il 1989 Sang Ye si è trasferito in Australia e con il suo lavoro continua a dar voce ai cinesi aiutandoci a comprendere l’attualità che li riguarda. Ha allargato il suo osservatorio anche a coloro che si sono trasferiti oltremare, e che dalla emigrazione ci fanno sentire le loro voci: voci che ha raccolto, ancora una volta, tramite il metodo dell’inchiesta collezionandole nelle interviste pubblicate sotto il titolo The Year the Dragon Came.
Un secolo di traduzioni in convegno
Non è certo un caso che, mentre l’impero di Cindia – secondo l’efficace neologismo adottato da Federico Rampini per definire la (non troppo ipotetica) aggregazione delle due nazioni più popolose del pianeta – si impone in tutto il mondo con la sua forza economica, siano sempre più numerosi in Italia i libri tradotti dal cinese. A lungo sconosciuta, e comunque molto trascurata, la letteratura cinese contemporanea ha cominciato a imporsi nel nostro paese nei primi anni Novanta, con la pubblicazione – per lo più da parte di Einaudi e della ormai defunta casa editrice romana Theoria – dei romanzi di Acheng, di Mo Yan, di Can Xue, di Han Shaogong, esponenti di quella nuova ondata di autori (la cosiddetta «generazione dell’ira»), che si era affacciata sulla scena letteraria di Pechino nel decennio precedente, raccontando in modo intenso e originale l’epoca della Rivoluzione culturale. Da allora l’elenco degli scrittori cinesi i cui libri sono stati tradotti in italiano si è a mano a mano infittito, a testimonianza da un lato della straordinaria vitalità di una letteratura sempre più incline alle sperimentazioni stilistiche, dall’altro dell’interesse crescente che il «fenomeno Cina» suscita nel nostro paese e in genere in Europa. (È del 2000 il Nobel per la letteratura assegnato all’intellettuale dissidente Gao Xingjian, mentre nel 2004 il Salon du Livre di Parigi ha dedicato una sontuosa vetrina alle «Lettres chinoises», escludendo però, in ossequio alla Realpolitik, proprio Gao). Intorno a questo rapido processo di penetrazione (ma anche agli anni che lo hanno preceduto) si dipanano domani e dopodomani i lavori di un convegno, «La letteratura cinese in Italia», che si tiene a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale. Organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 750° anniversario della nascita di Marco Polo, l’incontro prende avvio (fra l’altro con le relazioni di Edoarda Masi e di Anna Bujatti) offrendo spunti di riflessione sul rapporto inestricabile fra gli scrittori del Novecento – e in particolare Lu Xun – con le travagliate vicende politiche che hanno scosso la Cina nell’arco di tutto il secolo. E se Alessandra Lavagnino e Nicoletta Pesaro approfondiscono rispettivamente il tema della traduzione delle opere di Gao e l’evoluzione narrativa di un autore rappresentativo dell’avanguardia degli anni Novanta come Ge Fei, il vero fulcro del convegno è rappresentato dalla presenza a Roma di tre figure di spicco della narrativa cinese degli ultimi anni: Han Shaogong, Ma Yuan e Su Tong. Del primo, teorico del movimento per una «letteratura alla ricerca delle radici», il pubblico italiano conosce per ora soltanto il racconto lungo «Pa pa pa» tradotto da Maria Rita Masci per Theoria nel 1992, ma lo scrittore ha poi pubblicato diverse altre opere fra cui (nel 1997) «Un dizionario di Maqiao». Meno noto in Italia è il cinquantatreenne Ma Yuan, che con le sue narrazioni sulla cultura tibetana si è imposto, già a partire dagli anni Ottanta, come un esponente della letteratura cinese d’avanguardia. Soprattutto grazie al cinema (e in particolare a «Lanterne rosse» di Zhang Yimou, trasposizione di «Mogli e concubine») è infine conosciuto Su Tong, il cui ultimo romanzo, «Quando era imperatore», è uscito per Neri Pozza nel 2004.


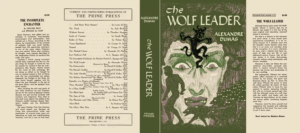


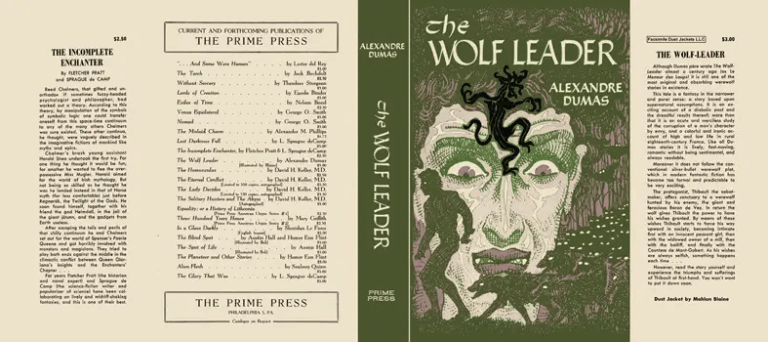

No Comments