«Nell’Iliade appaiono due modi di rappresentazione. Il primo si ha quando Omero descrive lo scudo di Achille: è una forma compiuta e conchiusa in cui Vulcano ha rappresentato tutto quello che egli sapeva e che noi si sa su una città, il suo contado, le sue guerre i suoi riti pacifici. L’altro modo si manifesta quando il poeta non riesce a dire quanti e chi fossero tutti i guerrieri Achei: chiede aiuto alle muse, ma deve limitarsi al cosiddetto, ed enorme, catalogo delle navi, che si conclude idealmente in un eccetera. Questo secondo modo di rappresentazione è la lista o elenco.
Ci sono liste che hanno fini pratici e sono finite, come la lista di tutti i libri di una biblioteca; ma ve ne sono altre che vogliono suggerire grandezze innumerabili e che si arrestano incomplete ai confini dell’indefinito. Come mostra questo libro e l’antologia che esso raccoglie, la storia della letteratura di tutti i tempi è infinitamente ricca di liste, da Esiodo a Joyce, da Ezechiele a Gadda. Sono spesso elenchi stesi per il gusto stesso dell’enumerazione, per la cantabilità dell’elenco o, ancora, per il piacere vertiginoso di riunire tra loro elementi privi di rapporto specifico, come accade nelle cosiddette enumerazioni caotiche.
Però con questo libro non si va solo alla scoperta di una forma letteraria di rado analizzata, ma si mostra anche come le arti figurative siano capaci di suggerire elenchi infiniti, anche quando la rappresentazione sembra severamente limitata dalla cornice del quadro. Così il lettore troverà in queste pagine una lista di immagini che ci fanno sentire la vertigine dell’illimitato.»
Con una citazione del Don Giovanni, questa è la descrizione che la casa editrice dà di questo volume, l’ultima fatica a cura di Umberto Eco che si va ad inserire nel solco delle sue altre due peregrinazioni nel mondo dell’arte: Storia della Bellezza ed Storia della Bruttezza, due la cui grazia non si può non venerare. E questo Vertigine della Lista, più complesso dal punto di vista concettuale e forse meno interessante per alcuni, non è sicuramente opera da meno. Cosa spinge l’artista, nel senso più ampio del termine, a rappresentare un elenco di elementi, a scegliere (o meno) un criterio secondo cui metterli in ordine, a determinare minuziosamente i caratteri distintivi di ogni elemento ed a comporli poi in un tutt’uno la cui estensione e magnificenza faccia mozzare il fiato? Secondo Eco, ciò che lo spinge è precisamente l’intento di togliere il respiro, di misurarsi e far misurare il lettore con la vastità dell’innumerabile, dargli un assaggio delle infinite varietà del reale e, di riflesso, mostrargli la potenza della rappresentazione.
Lo sviluppo del libro è semplice:
- Lo scudo e la forma. Partendo da Omero, da cui in effetti si può pensare tutto parta, ci si addentra nella descrizione dello scudo di Achille, una descrizione asslutamente iperbolica eppure racchiusa all’interno di una forma circolare, e si mette in chiaro che la rappresentazione descrittiva dell’infinito tramite lista rimane, comunque, una rappresentazione finita e circoscritta, evocativa dell’infinito ma che con essa non si può misurare a meno di peccare di hybris. Riferimento estetico: Quatremere de Quincy, Lo scudo di Achille da Le Jupiter olympien ou L’art de la sculpture antique (1815).
- L’elenco o la lista. Se lo scudo di Achille era la rappresentazione conclusa di un mondo noto all’autore, esistono raffigurazioni artistiche che si misurano con l’ignoto, con un infinito non concettuale come quello evocato da una lista molt estesa, bensì con un infinito reale, laddove per infinito reale si può anche intendere un numero molto elevato di cui non si conosce l’entità. Riferimento estetico: Albrecht Altdorfer, La battaglia di Isso o La battaglia di Alessandro Magno (1529).
- L’elenco visivo. Il concetto dell’elenco illimitato si scontra con la limitatezza degli strumenti della rappresentazione visiva e non, superandolo attraverso le allusioni: un capitolo abbastanza ripetitivo, se non fosse per il riferimento finale al Bolero di Ravel ed al suo uso nel cortometraggio di Rybczynski (la macia del comunismo). Peccato che non faccia menzione della lunga marcia verso l’omicidio e la distruzione di massa di un intero pianeta evolutosi a partire da una bottiglietta di coca cola, ma forse Bruno Bozzetto non era un riferimento sufficientemente colto.
- L’indicibile. Continuando ad esplorare il problema del conflitto tra finitezza degli strumenti rappresentativi e l’infinito che intendono evocare, viene introdotta la figura retorica dell’indicibilità, quell’espediente narrativo che dichiara non descrivibile ciò che comunque l’artista si appresta a descrivere. E’ uno strumento proprio della rappresentazione narrativa, ovviamente, eppure non estraneo alle arti visive laddove la non rappresentabilità della forma viene evocata dalla bizzarria (il baroccherrimo Paradiso di Roelant Savery, 1626, che non a caso aveva una passione per i paradisi terrestri e i dodo) o dall’indefinitezza (Enea e la Sibilla nell’Ade di Bruegel il Vecchio, 1600).



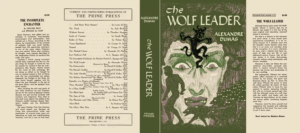


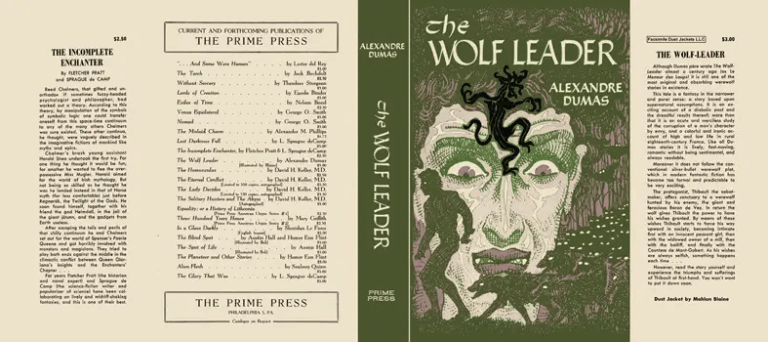
2 Comments
utente anonimo
Posted at 15:27h, 06 MarchPeccato che non abbia citato "Allegro non troppo" in effetti.
Non credo proprio che non lo conosca ed è per merito di Bozzetto se adoro il bolero.
Simone
Shelidon
Posted at 08:19h, 25 MarchAh, lo conosce senz'altro. Io adoro il valzer triste del gatto, anche se è tristissimo.