Dal Manifesto di oggi, due articoli che parlano di architettura.
Il primo è un pezzo di Franco Purini, un signore che…vabbé, avrò modo di dare gudizi di merito in seguito. Intanto, per chi non lo sapesse…
Franco Purini è un architetto e saggista italiano.
Nato in provincia di Frosinone, a Isola di Liri, nel 1941, ha studiato architettura a Roma con Ludovico Quaroni laureandosi nel 1971 e frequentando assiduamente gli ambienti degli artisti Franco Libertucci, Achille Perilli e Lorenzo Taiuti. Dopo un primo periodo di lavorocon Maurizio Sacripanti e Vittorio Gregotti, dal 1969, principalmente presso le università di Firenze e di Cosenza, Purini ha partecipato al laboratorio di progettazione “Belice ’80” e, dopo un breve periodo di insegnamento a Reggio Calabria e a Roma, è diventato docente presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dal 1966 inizia una lunga collaborazione a Roma con Laura Thermes, con cui parteciperà sia alla Biennale di Venezia che alla Triennale di Milano.
I suoi progetti sono densi di linee, rimandi, campiture, e le sue strutture dalla forte carica visionaria riecheggiano di razionalismo e tradizione classica, con chiare citazioni di Maurizio Sacripanti e Giovan Battista Piranesi. E’ accomunato a suoi colleghi contemporanei, come Francesco Cellini, Dario Passi e Pierluigi Eroli, proprio da questo uso del disegno come strumento di ricerca, che sfocia in una grande complessità grafica del progetto, oltre che in una carica fortemente simbolica delle sue opere, dense di sfalsamenti ed effetti chiaroscurali. A questo si unisce una ferrea logica progettuale, una sorta di impeccabile razionalismo.
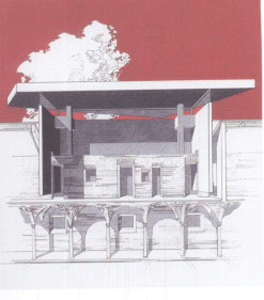 Ora, perché mi piace Franco Purini? E chi ha detto che mi piace? Lo trovo uno splendido disegnatore (in alto a destra, accanto al profilo, uno dei suoi divertissment grafici, del 1979), e come restauratore se la cava bene, considerato lo standard delle “riqualificazioni”. Si veda ad esempio l’elegante restauro delle scuderie medicee a Poggio Caiano (in cui comunque emerge il fastidio di Purini per la cura e il ricamo del dettaglio, come sottolinea giustamente Claudia Conforti nella citazione riportata da Casabella). La progettazione è tutt’altra cosa e porta all’estremo tutti i difetti che si possono riscontrare nel disegno e nel restauro. Più che razionalista e classicheggiante, come ho educatamente scritto nel profilo dell’enciclopedia, Purini è banalotto e fascisteggiante. Qualche esempio: il tremendo maniglione proposto per l’Ara Pacis, la casa del povero farmacista (laterale in perfetto stile “Esselunga Sotto Casa” e fronte con tanto di finestre finte e faccina che ride). Vi prego di tenere a mente questo mentre leggete il suo articolo, in cui si parla di Miloutine Borissavliévitch. Io mi sforzo sempre di ignorare la bruttezza dei progetti di Purini quando mi approccio alla sua prosa saggistica ma in questo caso avere a che fare con lo straordinario autore serbo, che non può che andare d’accordo con Renato De Fusco, lo porta ad una serie di commenti più o meno tra le righe non apprezzabili se non se ne conosce il retroterra. Di Renato De Fusco, come di Borissavliévitch, parlerò più tardi…
Ora, perché mi piace Franco Purini? E chi ha detto che mi piace? Lo trovo uno splendido disegnatore (in alto a destra, accanto al profilo, uno dei suoi divertissment grafici, del 1979), e come restauratore se la cava bene, considerato lo standard delle “riqualificazioni”. Si veda ad esempio l’elegante restauro delle scuderie medicee a Poggio Caiano (in cui comunque emerge il fastidio di Purini per la cura e il ricamo del dettaglio, come sottolinea giustamente Claudia Conforti nella citazione riportata da Casabella). La progettazione è tutt’altra cosa e porta all’estremo tutti i difetti che si possono riscontrare nel disegno e nel restauro. Più che razionalista e classicheggiante, come ho educatamente scritto nel profilo dell’enciclopedia, Purini è banalotto e fascisteggiante. Qualche esempio: il tremendo maniglione proposto per l’Ara Pacis, la casa del povero farmacista (laterale in perfetto stile “Esselunga Sotto Casa” e fronte con tanto di finestre finte e faccina che ride). Vi prego di tenere a mente questo mentre leggete il suo articolo, in cui si parla di Miloutine Borissavliévitch. Io mi sforzo sempre di ignorare la bruttezza dei progetti di Purini quando mi approccio alla sua prosa saggistica ma in questo caso avere a che fare con lo straordinario autore serbo, che non può che andare d’accordo con Renato De Fusco, lo porta ad una serie di commenti più o meno tra le righe non apprezzabili se non se ne conosce il retroterra. Di Renato De Fusco, come di Borissavliévitch, parlerò più tardi…
Eroici riepiloghi della tradizione alle soglie del contemporaneo – Franco Purini
Nato nel 1889 a Kragujevac, in Serbia, l’architetto Miloutine Borissavliévitch intraprese negli anni Venti a Parigi (dove sarebbe poi morto nel 1969) una fortunata carriera di saggista. Nel 1926, quando l’editore Payot diede alle stampe il suo volume Le teorie dell’architettura, il successo fu immediato in Francia e in molti altri paesi, anche se in Italia il lavoro fu oggetto di una stroncatura tanto veloce, quanto inappellabile da parte di Edoardo Persico. La ricerca teorica comunque non impedì a Borissavliévitch di svolgere una intensa attività di progettista in Serbia. Attività che si sarebbe concretizzata nei molti edifici attraverso i quali cercò di conciliare premodernità e modernità, unendole nel segno di una difficile e ambigua linea tematica e linguistica. Una estetica scientifica. Da poco pubblicato in italiano per le cure di Giorgio Pigafetta e Ilaria Abbondandolo, come primo di una collana di «Trattati per l’architettura moderna» diretta da Renato De Fusco, Le teorie dell’architettura (Editrice Compositori, pp. 207, euro 30) è un testo molteplice e complesso che si pone principalmente l’obiettivo di fondare una estetica scientifica dell’architettura. Per raggiungere questo risultato, Borissavliévitch passa in rassegna tutta la produzione trattatistica precedente, criticandone gli equivoci teorici, le approssimazioni espositive, le confusioni concettuali, le deviazioni psicologiche per arrivare a un nucleo problematico capace – a suo avviso – di dare vita a un nuovo pensiero architettonico. Nel loro utile ed esauriente saggio introduttivo, Giorgio Pigafetta e Ilaria Abbondandolo – oltre a tracciare un profilo dell’autore analizzandone l’opera architettonica con precisione e completezza critica – sottolineano due questioni di grande rilevanza. La prima consiste nell’assegnare Miloutine Borissavliévitch a quella linea di ricerca che, all’inizio del secolo scorso, «ha rifiutato l’irrompere del novum come elemento determinante della dinamica artistica del Novecento». Per i due prefatori, Borissavliévitch apparterrebbe a ciò che molti definiscono l’altro moderno, vale a dire quell’orientamento disciplinare «che si ispira alla continuità con le esperienze architettoniche del passato e che ne vuole adeguare la logica alla vita contemporanea». Modernità allargata. La seconda questione è data dal fatto che – osservano Pigafetta e Abbondandolo – l’architetto serbo «impegna costantemente il lettore in una analisi dell’architettura incentrata sull’idea di composizione». Questa scelta avrebbe permesso all’autore delle Teorie dell’architettura di aprirsi «alla comprensione della logica con cui si presenta la facies della città europea della prima metà del Novecento», un organismo urbano frutto della sovrapposizione dei linguaggi del passato. Al contempo, una simile scelta si sarebbe rivolta al rapporto con la città esistente. La lettura dell’opera di Miloutine Borissavliévitch consente in effetti di ampliare la nozione di modernità sottraendola a quella identificazione schematica con la relazione tra avanguardie e Bauhaus, nel momento stesso in cui cerca di ricondurre la sostanza della riflessione sull’architettura al luogo primario del comporre. Testo assai denso e stratificato, che parte dall’antichità per giungere fino ai primi anni del Novecento, Le teorie dell’architettura si articola in cinque capitoli, a loro volta suddivisi in sezioni più brevi e in paragrafi, seguiti da una conclusione nella quale si riassumono le fila di un discorso quanto mai arduo. Così, nel primo capitolo l’autore sintetizza un lungo percorso, e riassume in concisi paragrafi le concezioni sull’architettura di Platone, Aristotele, Vitruvio, per poi passare al Medioevo con Sant’Agostino e al Rinascimento con Leon Battista Alberti, Andrea Palladio, e infine affrontare le produzioni teoriche sull’architettura elaborate in Germania e in Inghilterra. Delineato questo quadro generale, l’autore entra nel merito di questioni relative al fenomeno architettonico inteso nelle sue qualità specifiche. Ecco allora emergere per un verso l’inferiorità dell’architettura in quanto arte che si esprime indirettamente, non avendo come modello – cosa che è invece propria della pittura e della scultura – la figura umana. Ovviamente, in questo passaggio del suo trattato, l’autore dimostra di non condividere la rivoluzione dell’astrattismo avvenuta all’inizio del Novecento. Tuttavia, sostiene Borissavliévitch, l’architettura è al tempo stesso superiore alle altre arti, proprio perché non è imitativa. Un’altra distinzione introdotta nel suo studio riguarda il senso da attribuire alle metafore architettoniche suscitate da ciò che in genere si definisce Einfühlung o empatia simbolica. Per l’autore infatti l’immedesimazione nell’opera non deve mai oltrepassare il piano fisiologico per introdursi nel territorio indefinibile e mutevole delle impressioni psicologiche. Ove questo avvenisse, si vanificherebbe la possibilità stessa dell’impostazione scientifica dell’estetica architettonica. Viene infine enunciato uno dei concetti portanti dell’intera opera, ossia la differenza tra prospettiva lineare e prospettiva ottico-fisiologica. La prima è l’esito di una concezione astratta dell’architettura, basata su una semplificazione geometrica, la seconda corrisponderebbe a ciò che avviene realmente nel rapporto tra un osservatore e un’architettura, essendo tale rapporto basato sulla concretezza organica dei processi visivi. Nel terzo capitolo Borissavliévitch sottopone a un attento esame critico alcune fra le principali teorie sull’estetica dell’architettura, partendo dall’Italia. A un’analisi circostanziata delle tesi vitruviane, dalle quali si mettono in rilievo le molte imprecisioni, segue una altrettanto diligente escursione attorno agli enunciati di Leon Battista Alberti. Di Vitruvio vengono indagate soprattutto le nozioni di simmetria ed euritmia. L’idea di proporzione è messa in relazione con quella di modulo all’interno di un chiarimento sulla differenza sostanziale che intercorre tra una misura e le modalità compositive al cui interno essa è utilizzata. Per quanto riguarda il trattato dell’Alberti è il concetto di lineamenta, ovvero di disegno, assente in Vitruvio, che occupa il centro della sua argomentazione. Un concetto che Borissavliévitch ritiene più confuso che complesso. Passando in rassegna le figure più importanti dell’architettura francese, l’architetto serbo – dopo aver proposto un riassunto esatto e circostanziato delle idee elaborate dai maggiori teorici d’oltralpe -affronta le argomentazioni proposte da Eugéne Viollet-le-Duc. In particolare, del grande precursore della modernità, Borissavliévitch considera importante l’idea del triangolo come figura generatrice dell’architettura mentre ne critica le riflessioni sulla visione ottica. Occupandosi poi della Germania, Borissavliévitch critica significativamente l’idea, formulata da Konrad Schopenhauer, secondo cui l’architettura si ridurrebbe alla dialettica tettonica tra carico e sostegno. Ancora da segnalare in questa panoramica tedesca sono una attenta disanima della teoria di August Thiersch sull’analogia, in base alla quale vengono avanzate alcune ipotesi sulla proporzione (puntualmente corrette dall’autore) e la lettura delle tesi di Heinrich Wölfflin sull’Einfühlung, in cui l’architetto ravvisa una confusione tra il punto di vista fisiologico e quello psicologico. All’Inghilterra è riservato il quinto capitolo del libro, capitolo occupato quasi per intero da una lunga dissertazione sulla teoria di John Belcher, del quale lo studioso serbo apprezza la scelta di riferirsi empiricamente agli esempi anche se gli rimprovera che molte delle sue «considerazioni non avevano alcun rapporto con la scienza dell’estetica e con i fenomeni che essa studia». L’autore riserva poi la parte conclusiva del libro per ribadire il senso del suo progetto di ricerca, ribadendo l’originalità e la necessità della sua costruzione scientifica, a fronte delle affermazioni errate, delle approssimazioni e delle deviazioni nel campo della psicologia rilevate nel corso della sua lunga esposizione. La proposta teorica formulata nel libro dell’architetto serbo si potrebbe sintetizzare in due principi. Da un lato, quello relativo all’armonia che si riassume nella «loi du même», che implica la ripetizione dello stesso elemento, volta per volta variato secondo modalità particolari. Un altro principio è dato dalla «loi du semblable» che concerne, appunto, la prospettiva ottico-fisiologica. Un libro terminale. L’idea che ogni facciata sia una prospettiva costruita è indubbiamente di notevole interesse nonché di grande novità, proponendosi come il contributo più significativo offerto da Miloutine Borissavliévitch all’architettura. Pubblicato nel 1926, tre anni dopo Verso un’architettura di Le Corbusier, quello di Miloutine Borissavliévitch – ora proposto anche al lettore italiano – è un libro terminale. Offre la sintesi di una ricerca millenaria che si arresta alle soglie della modernità senza entrarci. Anche se i due curatori, Giorgio Pigafetta e Ilaria Abbondandolo, vedono in questa opera una reazione all’imposizione del nuovo da parte delle avanguardie, la loro opinione, anche quando viene sostenuta con grande convinzione, non sembra del tutto condivisibile. Il saggio appare più come l’eroico riepilogo di una intera tradizione di pensiero, il cui autore non sembra, però, aver voluto misurarsi con le condizioni poste dalla rivoluzione dalle avanguardie, primo fra tutti la scissione del linguaggio dai suoi stessi contenuti. È questa divaricazione ad aver permesso al linguaggio di evolversi in autonomia, iscrivendosi in una sua completa autoreferenzialità. Essa, però, è del tutto assente in questa poderosa esplorazione dell’universo trattatistico, al cui centro c’è ancora l’oggetto architettonico nella sua unità morfologica e nell’interesse della sua costruzione prospettica, laddove la modernità preferisce sciogliere l’oggetto architettonico in una processualità formativa e in una sequenza cubista di più visioni simultanee. Contrasti vitali. Lo spazio di cui parla Miloutine Borissavliévitch è, tuttavia, ancora uno spazio statico, governato e retto da regole stabili, mentre la modernità, nelle sue varie declinazioni, ha scelto la direzione della scomposizione, della compenetrazione dinamica, del montaggio, del frammento. L’importanza del libro non risiede dunque in una sua potenziale attualità, ma nella centralità del problema che esso pone, vale a dire la necessità di una costruzione, per quanto più possibile scientifica, dell’architettura e della sua estetica. Una visione scientifica che oggi è attribuita, nell’opinione corrente, solo all’high-tech e alle problematiche dell’architettura ambientale, mentre dovrebbe essere ricondotta al più presto alla totalità irrinunciabile del fenomeno architettonico, visto in tutte le sue diverse e a volte contrastanti componenti.
La solita critica dei razionalisti: chi non vede l’architettura come me, non si pone all’interno dell’epoca moderna. Ora, checché ne dica l’arrabbiato Purini, il saggio viene pubblicato come apripista di una collana perché è un “libro terminale”? A questa domanda cerca di rispondere questo trafiletto redazionale, posto accanto all’articolo di Purini sempre nel Manifesto di oggi.
Segnali di nuova architettura fra le pagine
Nel ricco, ma anche piuttosto convenzionale, panorama dell’editoria italiana specializzata sul tema dell’architettura, va segnalata una iniziativa coraggiosa e a suo modo unica. Si tratta della collana «Trattati per l’architettura moderna» avviata dalla casa editrice Compositori, per la cura di Renato De Fusco. Nella sua introduzione al progetto, De Fusco richiama l’attenzione su quelli che sono e saranno i temi portanti dello stesso, in particolare «le nozioni di moderno e di storiografia». Sulla storiografia, De Fusco chiarisce che «non è la storia a divenire di colpo contemporanea, quanto piuttosto la storiografia» a non poter essere altro che «il frutto di ciò che pensiamo oggi». Nonostante l’impegno che i volumi della collana richiederanno ai loro lettori sarebbe sbagliato pensare che questa iniziativa sia destinata solo al circolo ristretto degli specialisti di teoria architettonica. Al contrario, i testi di cui è stata programmata l’uscita costituiscono, per il vasto pubblico dell’architettura, uno strumento utile per ampliare la conoscenza delle idee dalle quali è dipesa e dipende l’evoluzione della ricerca in questa disciplina. Il piano della collana, che prevede per ora la pubblicazione di testi di storici e di teorici notevoli – tra i quali Gustav Adolf Platz, Henry Russell Hitchcock, Walter Kurt Behrendt, August Schmarsow, Herman Sörgel, Gustavo Giovannoni, Henry Focillon, Giulio Carlo Argan, Carlo Levi, Giuseppe Pagano, Lionello Venturi, Roberto Salvini, Adolf Behne, Walter Gropius, Salvatore Vitale – si presenta dunque come un’operazione di grande respiro, che può restituire all’editoria italiana di settore un ruolo avanzato e sperimentale, contribuendo a sottrarla a mere esigenze illustrative e divulgative. Ogni trattato sarà preceduto da un saggio introduttivo il quale, mentre contestualizzerà l’opera nell’ambito delle problematiche attuali, consentirà ai lettori di comprendere in tutta la loro ampiezza le tematiche esposte.
Basta dare una piccola scorsa ai profili degli autori linkati per rendersi conto di quale sia il taglio della nuova collana: storici dell’arte e dell’architettura e una grande quantità di progettisti antifascisti (e non antimoderni, come forse direbbe qualcuno): l’osteggiatissimo Gustavo Giovannoni da sempre additato come anti-moderno, Giulio Carlo Argan, Carlo Levi, Vittorino Venturi che per il suo antifascismo perse la cattedra, il “redento” Giuseppe Pagano.
Orbene, Renato De Fusco. Chi è costui, che osa? Renato De Fusco è uno storico dell’architettura, ordinario all’università Federico II di Napoli, e si è già attirato le ire di numerosi progettisti per le sue posizioni ritenute tradizionaliste (e ridaje) in difesa di un’architettura connotata territorialmente, rispettosa delle preesistenze: De Fusco non ha mai fatto mistero sulle sue perplessità riguardo a molt mostri sacri dell’architettura modrna, né ha mancato di sottolineare la perversione di un meccanismo secondo il quale chi ha teorizzato in passato il distacco dai modelli e dai canoni è diventato a sua volta modello e canone imprescindibile. Corsi e ricorsi della progettazione. Ed è stupefacente come oggi, per essere rivoluzionari e innoativi, si debba essere tradizionalisti…

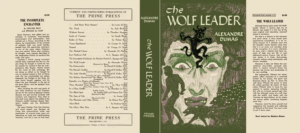


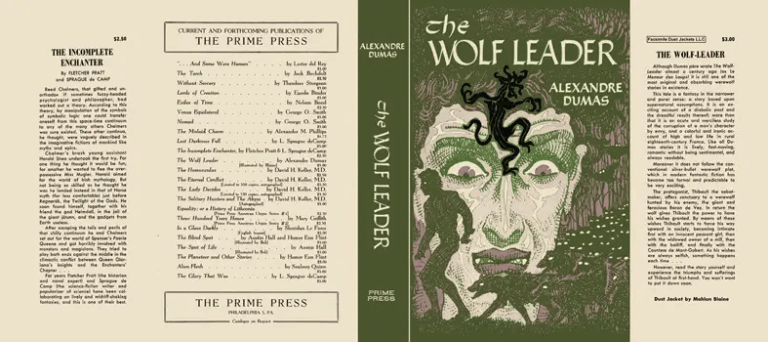


2 Comments
betazed
Posted at 10:08h, 08 Julybello questo posto!
grazie del bignami di piacevolezza e cultura.
betazed
Shelidon
Posted at 10:56h, 08 JulyGrazie a te!