Il Manifesto di ieri regalava questa perla che non posso non girarvi. E dire che io adori Saramago quando parla dei luoghi è un eufemismo.
Dai miei ricordi di infanzia – José Saramago
Anticipiamo qualche brano dall’ultimo libro dello scrittore portoghese, in uscita in questi giorni con il titolo «Le piccole memorie», tradotto da Rita Desti per Einaudi. Il memoir ha inizio con la descrizione del paese in cui nacque, Azinhaga, e termina evocando una scena che ebbe luogo nell’orto dei nonni. I sottotitoli sono redazionali
Ho raccontato altrove come e perché mi chiamo Saramago. Che quel Saramago non era un cognome per parte paterna, bensí il soprannome con cui era conosciuta la mia famiglia nel paese. Che quando mio padre andò a dichiarare all’Anagrafe di Golegã la nascita del suo secondo figlio, capitò che l’impiegato (si chiamava Silvino) fosse ubriaco (indignato, di questo lo avrebbe sempre accusato mio padre) e che, nei fumi dell’alcol e senza che nessuno si accorgesse dell’onomastica frode, decidesse, a suo rischio e pericolo, di aggiungere Saramago al laconico José de Sousa che mio padre voleva che fossi. E che, in questo modo, infine, grazie a un intervento a tutte le evidenze divino, mi riferisco, è chiaro, a Bacco, dio del vino e di coloro che eccedono nel berlo, non ho avuto bisogno di inventare uno pseudonimo, caso mai ci fosse stato un futuro, per firmare i miei libri. Fortuna, gran fortuna la mia, fu di non essere nato in qualcuna delle famiglie di Azinhaga che, a quel tempo e per molti altri anni, dovettero portarsi appresso dei soprannomi osceni come Pichatada, Curroto e Caralhana, come a dire pirlotto, minchione e sbelinato. Entrai dunque nella vita… Entrai dunque nella vita indicato con questo cognome Saramago senza che la famiglia lo sospettasse, e fu solo all’età di sette anni, quando, per iscrivermi alla scuola elementare, fu necessario presentare un certificato di nascita, che la verità nuda e cruda venne a galla nel pozzo burocratico, con grande indignazione di mio padre al quale, da quando si era trasferito a Lisbona, quel soprannome non piaceva. Ma il peggio di tutto fu quando, chiamandosi lui unicamente José de Sousa, come si poteva leggere nei suoi documenti, la Legge, severa, diffidente, volle sapere perché accidenti avesse allora un figlio il cui nome completo era José de Sousa Saramago. A questa intimazione, e perché tutto si sistemasse nel giusto, nel sano e nell’onesto, mio padre non poté fare altro che procedere a una nuova iscrizione del proprio nome, passando a chiamarsi, lui pure, José de Sousa Saramago. Suppongo che dovrà essere stato questo l’unico caso, nella storia dell’umanità, in cui sia stato il figlio a dare il nome al padre. Non ci serví a molto, né a noi né a lei, perché mio padre, saldo nelle sue antipatie, sempre volle e ottenne che lo chiamassero unicamente Sousa. Un giorno, un nostro vicino, e dico vicino perché abitava nella nostra stessa strada (era ancora quella di Padre Sena Freitas), non perché ci conoscessimo, un uomo giovane, poco piú che ventenne, diede di matto. Si diceva che avesse perso il senno dal molto leggere e molto studiare. Come Don Chisciotte. Mi ricordo della crisi che gli venne, l’unica di cui fummo testimoni oculari, perché poi non venimmo a saperne piú niente, la cosa piú probabile è che lo avessero ricoverato a Rilhafoles, che era come si chiamava il manicomio. All’improvviso cominciammo… All’improvviso cominciammo a udire da fuori delle grida angosciate, strazianti, e corremmo a una finestra, mia madre, Conceiçâo e io, per scoprire che cosa stava succedendo. Lui abitava all’ultimo piano di un palazzo ben piú alto del nostro, dall’altro lato della strada e un po’ verso destra rispetto alla casa in cui vivevamo noi, un edificio ad angolo con Rua Cesário Verde. Lo vedemmo comparire alla finestra, piú volte, come se volesse gettarsi di sotto, tant’è che dietro di lui spuntavano immediatamente delle mani che lo trattenevano, e lui si dibatteva, urlava da spezzarti il cuore, e ripeteva sempre le stesse parole: «Ah, Sant’Ilario! Ah, Sant’Ilario!» Il perché di quell’appello a Sant’Ilario non venimmo mai a saperlo. A un certo momento arrivò un’ambulanza, che doveva essere dei pompieri, ce lo infilarono dentro e non tornò mai piú, per lo meno finché abitammo lí. A quell’epoca frequentavo già la Scuola Industriale Afonso Domingues, a Xabregas, dopo due brevi anni passati al Liceo Gil Vicente, allora situato nel Convento di São Vicente de Fora. A rigore, la cronologia dei miei scarsi studi è questa: entrai alle medie nel 1933, ancora a dieci anni (le lezioni cominciavano a ottobre e il mio compleanno è a novembre), ci rimasi negli anni scolastici 1933- 1934 e 1934-1935, e passai alla Afonso Domingues quando stavo per compiere tredici anni. Bisogna tener conto che nelle discipline tecniche, come Officina, Meccanica e Disegno di Macchine, che ovviamente non facevano parte del programma delle medie, mi ritrovai un anno indietro alla Afonso Domingues, e cioè entrai al primo anno in quelle materie e al secondo nelle rimanenti. Fu questa, dunque, la sequenza delle mie frequenze scolastiche nella scuola industriale: ’35-’36, secondo e primo; ’36-’37, terzo e secondo; ’37-’38, quarto e terzo; ’38-’39, quinto e quarto; ’39-’40, quinto. La gita a Sameiro, quella del cavallo che non volle salutarmi, si fece alla fine dell’anno scolastico ’38-’39, ma prima degli esami, e in quell’occasione ebbi la sfortuna di storcermi il piede sinistro facendo un salto, con il risultato di una incrinatura al calcagno che mi obbligò a camminare per piú di un mese con uno stivale di bende gessate fino al ginocchio, il quale poggiava a terra grazie a un ferro ricurvo le cui punte erano inserite nel gesso e che chiamavano staffa. Quello stivale di gesso fu festeggiatissimo con firme, disegni e scarabocchi vari dai compagni. A uno di loro venne persino l’idea che avrei potuto approfittarne per lo scritto di Matematica: «Ti tiri su i calzoni, ed è fatta». Nonostante non avessi seguito il consiglio, fui promosso. Credo che l’occasione sia buona per parlare di un altro episodio collegato alla mia comparsa su questo mondo. Come se già non bastasse il delicato problema d’identità suscitato dal cognome, venne ad aggiungersene un altro, quello della data di nascita. In realtà, io sono nato il 16 novembre 1922, alle due del pomeriggio, e non il 18, come afferma la Conservatoria dell’Anagrafe. Si dà il caso che in quel periodo mio padre si trovasse a lavorare fuori paese, lontano, e oltre a non essere stato presente alla nascita del figlio, poté rientrare a casa solo dopo il 16 dicembre, molto probabilmente il 17, che era una domenica. Fatto sta che allora, e suppongo ancora oggi, la dichiarazione di una nascita andava fatta entro trenta giorni, pena una multa in caso di infrazione. Dal momento che a quei tempi patriarcali, trattandosi di un figlio legittimo, non sarebbe passato per la mente a nessuno che la partecipazione venisse fatta dalla madre o da un parente, e tenendo conto che il padre era considerato ufficialmente l’autore unico del nato (nella mia scheda di iscrizione al Liceo Gil Vicente risulta solo il nome di mio padre, non quello di mia madre), si aspettò che lui rientrasse e, per non dover sborsare la multa (qualsiasi somma, sia pure piccola, sarebbe stata eccessiva per le tasche della famiglia), si posticipò di due giorni la data reale della nascita, e il caso fu risolto. Essendo la vita ad Azinhaga quella che era, penosa, difficile, spesso gli uomini andavano a lavorare fuori per settimane, perciò non sarò stato di certo né il primo caso né l’ultimo colpevole di queste piccole frodi. Rispetto alla data di nascita che risulta nella carta di identità morirò due giorni piú vecchio, ma spero che la differenza non si noti troppo. (…) Imparai in fretta a leggere. Grazie al lustro di istruzione che avevo cominciato a ricevere nella mia prima scuola, quella di Rua Martens Ferrão, di cui riesco a rammentare solo l’entrata e la scalinata sempre buia, passai, quasi senza transizione, alla frequenza regolare degli studi superiori della lingua portoghese nella figura di un giornale, il «Diário de Notícias», che mio padre portava a casa tutti i giorni e che suppongo gli fosse offerto da qualche amico, un giornalaio, forse il padrone di una tabaccheria. Comprare, non credo lo comprasse, per la pertinente ragione che non ci avanzava denaro da sprecare in simili lussi. Per dare un’idea chiara della situazione, basterà dire che per anni, con assoluta regolarità stagionale, mia madre andava a portare le coperte al monte di pietà quando l’inverno terminava, per riscattarle solo, risparmiando centesimo su centesimo per poter pagare gli interessi tutti i mesi e il recupero finale, quando i primi freddi cominciavano a farsi sentire. Ovviamente, non avrei saputo leggere di filato il già allora storico giornale del mattino, ma una cosa mi era chiara: le notizie erano scritte con gli stessi caratteri (noi le chiamavamo lettere, non caratteri) dei quali stavo imparando a scuola nomi, funzioni e reciproci rapporti. Di modo che, sapendo sillabare ancora a stento, già leggevo, senza accorgermi che stavo leggendo. Identificare nello scritto del giornale una parola che conoscevo era come trovare lungo la strada un cippo lí a dirmi che andavo bene, che ero nella direzione giusta. E fu così, in questa maniera un po’ inusuale, «Diário» dopo «Diário», mese dopo mese, facendo finta di non udire le battute degli adulti di casa che si divertivano perché me ne stavo lì a guardare il giornale come se fosse un muro, che giunse il mio momento di lasciarli a bocca aperta quando, un giorno, d’un fiato lessi a voce alta, senza titubare, nervoso ma trionfante, un certo numero di righe di seguito. Non capivo tutto quello che leggevo, ma questo non importava. Oltre a mio padre e mia madre, i suddetti adulti, prima scettici, ora soggiogati, erano i Barata. Orbene, accadde che in quella casa dove non c’erano libri, un libro c’era, uno solo, grosso, rilegato, se non erro, in azzurro chiaro, che si intitolava La capinera del mulino e il cui autore, se la mia memoria ci azzecca anche questa volta, era Émile de Richebourg, al cui nome le storie della letteratura francese, anche le più minuziose, non credo facciano granché caso, ammesso che lo abbiano mai considerato, ma che fu persona abilissima nell’arte di esplorare con la parola i cuori sensibili e i sentimentalismi più impetuosi. La proprietaria… La proprietaria di questo gioiello letterario assoluto, da tutti gli indizi risultante anch’esso da una previa pubblicazione in fascicoli, era Conceição Barata, che lo teneva in serbo come un tesoro in un cassetto del comò, avvolto in carta velina, con odore di naftalina. Questo romanzo sarebbe divenuto la mia prima grande esperienza di lettore. Ero ancora ben lontano dalla biblioteca del Palazzo das Galveias, ma il primo passo per arrivarci era stato fatto. E dato che la nostra famiglia e quella dei Barata vissero insieme per un buon paio d’anni, il tempo mi fu più che sufficiente per ultimare la lettura e ricominciare da capo. Contrariamente, però, a quello che mi era successo con Maria, la fata dei boschi, non riesco, per quanto abbia tentato, a rammentare un solo brano del libro. Émile de Richebourg non gradirebbe questa mancanza di considerazione, lui che pensava di avere scritto la sua Capinera con inchiostro indelebile. Ma le cose non si sarebbero fermate qui. Anni dopo sarei venuto a scoprire, con la più grande delle sorprese, che in quel sesto piano di Rua Fernão Lopes avevo letto anche Molière. Un giorno mio padre si presentò a casa con un libro (non riesco a immaginare come potesse averlo avuto proprio lui) che era niente di meno che una guida di conversazione portoghese-francese, con le pagine divise in tre colonne, la prima, a sinistra, in portoghese, la seconda, centrale, in lingua francese, e la terza, accanto a quest’ultima, che riproduceva la pronuncia delle parole della seconda colonna. Tra le varie situazioni… Tra le varie situazioni in cui si sarebbe potuto trovare un portoghese che dovesse comunicare in francese con l’aiuto della guida di conversazione (in una stazione ferroviaria, alla reception di un albergo, in un noleggio di carrozze, in un porto marittimo, da un sarto, ad acquistare i biglietti per il teatro, a provare un abito dal sarto, eccetera), compariva inopinatamente un dialogo fra due persone, due uomini, uno dei quali era qualcosa tipo un maestro e l’altro una specie di allievo. Lo lessi molte volte perché mi divertiva lo stupore dell’uomo che non poteva credere a quello che il professore gli diceva, che lui faceva prosa sin dalla nascita. Io non sapevo niente di Molière (e come avrei potuto saperlo?), ma ebbi accesso al suo mondo, entrando dalla porta principale, quando ancora avevo superato a stento l’a-e-i-o-u. Non c’era dubbio, ero un ragazzo fortunato.
© José Saramago & Editorial Caminho SA, Lisboa 2006. By arrangement with dr. Ray Gude Mertin Literarische Agentur Bad Homburg Germany
Bibliografia Saramago
Dopo un esordio narrativo precoce, affidato alla «Terra del peccato», seguì una lunga trentennale parentesi in cui Saramago si dedicò al giornalismo. Ma all’indomani della rivoluzione dei Garofani, una sorta di contro-golpe «democratico» fece naufragare le aspirazioni socialiste del primo governo succeduto alla dittatura e Saramago, in quanto comunista, perse il posto. Fu così che tornò al romanzo con il «Manuale di pittura e calligrafia». Tra gli altri titoli, «Memoriale del convento», dove la narrazione insegue l’eroismo della povera gente, «Una terra chiamata Alentejo», la saga di quattro generazioni contadine, «L’anno della morte di Riccardo Reis» in cui fa i conti con Pessoa, e quella sorta di polittico sulla condizione umana, che comprende «Cecità», «Tutti i nomi», «La caverna», «L’Uomo duplicato». Gli ultimi ro0manzi sono «Saggio sulla lucidità» e «Le intermittenze della morte» tutti tradotti da Rita Desti per Einaudi.



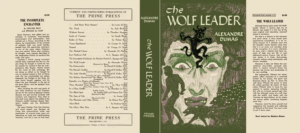


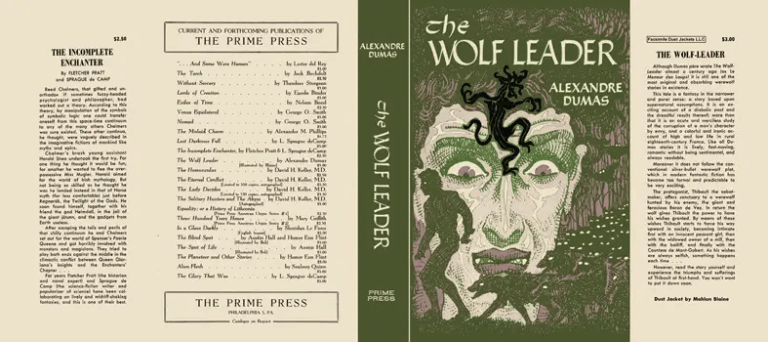
2 Comments
PaoloFerrucci
Posted at 09:10h, 08 JuneGran post, Shelidon. Saramago è diventato veramente scrittore in età matura, e questo vale da grande esempio, secondo me.
buona giornata :)
Shelidon
Posted at 09:23h, 08 JuneSapevo che avresti apprezzato *__^
Il mio libro favorito di Saramago, devo ammetterlo, è un libro un po’ atipico che tra le mie preferenze supera Cecità, Il vangelo secondo Gesù Cristo e, addirittura (anche se di poco), Manuale di pittura e calligrafia: Viaggio in Portogallo. Sarà perché mi sono innamorata di quel Paese in viaggio di studio, sarà perché adoro i libri di viaggio, le storie di viaggi e, naturalmente, viaggiare (ma quel tipo di viaggio che si sofferma in un luogo e lo vive, restando impregnato dei suoi odori e sapori), sarà perché sotto sotto sono inguaribilmente sentimentale.