 Una rivista per la civiltà del vivere quotidiano – Lucia Tozzi
Una rivista per la civiltà del vivere quotidiano – Lucia Tozzi
Sfogliare il primo volume della monumentale edizione di domus pubblicata da Taschen può rivelarsi un’esperienza straniante: le copertine delle annate 1928-1939 e le pagine selezionate dagli stessi numeri, infatti, sembrano appartenere a due mondi radicalmente distanti. I caratteri aggraziati dell’intestazione, le marche inconfondibili dell’era fascista, e soprattutto le fotografie di vasi alabastrini, bronzetti, porcellane, fasci littori, gioielli e altri oggetti preziosi che figurano sui frontespizi ordinati per anno stridono fragorosamente con le architetture razionaliste della mostra di Stoccarda del 1927, della Werkbundsiedlung di Vienna del 1929, delle Triennali, di Terragni, Le Corbusier, Neutra, BBPR, Libera che illustrano i contenuti della rivista. Certamente è la personalità intellettuale di Gio Ponti, il creatore di domus, a essere largamente responsabile di questo spiazzamento. Curioso, vorace, intriso di una cultura del fare che ricorda per certi aspetti la prensilità di Lucio Fontana, Ponti ha sempre accanitamente mediato tra posizioni e pratiche contrapposte. Senza mai abbandonare il classicismo novecentista, ha sostenuto con crescente passione le ragioni e le soluzioni di un razionalismo moderato, spogliato di ogni valenza ideologica e privo di qualsiasi contatto con le polemiche contingenti.
Il problema della casa. Il suo obiettivo era quello di formare un gusto architettonico nuovo, capace di accogliere all’interno della tradizione italiana le forme, le scoperte, i materiali messi a punto dai più brillanti architetti internazionali, di ripudiare lo spreco di spazio e la volgarità degli stili eclettici e monumentali. Per descrivere il suo gusto lo sintetizzava così: «una conoscenza umana e appassionata d’ogni movimento d’arte e cultura». E aggiungeva: «È educazione, dunque, è un fatto attivo, non è una moda, cioè un fatto da subire». L’imperativo di un atteggiamento antidogmatico e l’esigenza di evitare ogni unilateralismo spingevano la ricerca di Gio Ponti lontano dal campo teorico, facendo convergere la trama intricata dei suoi interessi, desideri e curiosità sul problema della casa. La casa all’italiana, come titolava il primo editoriale della rivista, non ha nulla a che spartire con la machine à habiter di Le Corbusier, espressione del più puro funzionalismo, «il suo disegno non discende dalle sole esigenze materiali del vivere – si legge – ma offre, attraverso la naturale continuità architettonica tra interno ed esterno, l’ordinata semplicità dei suoi spazi adatti ad accogliere suppellettili e opere d’arte: un «invito al nostro spirito di ricrearsi in riposanti visioni di pace, nel che consiste nel pieno senso della bella parola italiana, Conforto». Nei piani di Ponti, i consigli pratici per «la massaia moderna», le rassegne di oggetti di artigianato, le pubblicità delle raffinate ceramiche Richard-Ginori (di cui Ponti era direttore artistico) si accordavano quindi senza difficoltà ai modelli abitativi del Movimento Moderno, perché concorrevano in egual misura al rinnovamento della «quotidiana civiltà del vivere», di una domesticità presa come punto di riferimento per una visione sociale fondata sulla famiglia.
Design e grafica protagonisti. La nascita della rivista, d’altra parte, risale a una proposta di Giovanni Semeria, predicatore barnabita entrato in contatto con Ponti grazie alla mediazione di Ugo Ojetti, scrittore e critico «del consenso», le cui idee erano inequivocabilmente tradizionaliste. Se è vero che dopo un solo anno, con la costituzione della editoriale domus – formata dal giovanissimo Gianni Mazzocchi e dallo stesso Ponti in qualità di presidente – padre Semeria usciva di scena, il sostrato religioso della concezione sociale e architettonica di Ponti non viene mai meno, e anzi si rafforzò nell’incontro con il critico Giovanni Persico alla metà degli anni Trenta. Al di fuori delle succinte ricostruzioni storiche contenute nei saggi introduttivi di Luigi Spinelli e Fulvio Irace (e, appunto, delle copertine), è però molto difficile rintracciare nell’edizione Taschen i segni di questa cultura: i curatori Charlotte e Peter Fiell hanno con ogni evidenza scelto di privilegiare la linea internazionale e moderna di domus, assegnado una particolare attenzione al design e alla grafica, e utilizzando come pietra di paragone il periodo di massimo splendore della rivista, vale a dire gli anni Sessanta, con le magnifiche anticipazioni degli anni Cinquanta e la successiva fase radical. Il risultato di questa scelta è un prodotto che fa gola, un repertorio luccicante e colorato di immagini meravigliose e ben riprodotte, che documenta le migliori produzioni grafiche, le più belle opere di architettura, i più famosi oggetti di design mai progettati, selezionati attraverso un criterio molto contemporaneo, quello dello star-system internazionale. Questo immenso archivio permette di ricomporre intere genealogie visive, rende conto dell’evoluzione delle tecniche, della contaminazione tra i generi, degli intrecci tra media, e testimonia del ruolo egemonico che domus ha giocato internazionalmente in questo campo. Il brillante taglio editoriale ha però inevitabilmente imposto il sacrificio della parte testuale e del coté milanese di domus, compromettendo di fatto l’utilità scientifica dei volumi. La compressione degli anni Trenta e Quaranta in due tomi anziché quattro è la testimonianza più drastica di questa operazione di decontestualizzazione storica e geografica, interpretabile forse anche alla luce del perenne imbarazzo critico che ristagna intorno alla figura di Gio Ponti; o forse leggibile come adesione al punto di vista di Mazzocchi più che a quello di Ponti, che mentre era incline a celebrare l’ormai indiscusso prestigio intellettuale e commerciale della maturità, rimuoveva le ambiguità legate al proprio esordio. Identificare le vicende di quegli anni con la felicità creativa e la tensione verso l’architettura europea di Ponti significa banalizzare profondamente l’importanza della funzione svolta da domus all’interno di un sistema complesso di relazioni qual è stato quello del mondo dell’architettura durante il fascismo – l’unico regime totalitario europeo che non ha imposto un’arte di stato – e nel periodo della ricostruzione postbellica. La facile contrapposizione tra la Casabella di Giuseppe Pagano Pogatschnig, polemica e di parte e l’apollinea domus non rende giustizia né all’una né all’altra: nel complicatissimo panorama architettonico italiano, dominato dal farsi e disfarsi dei gruppi (la «cerchia di Gualino» a Torino, il Gruppo 7 a Milano, il Gur e il Miar a Roma, Novecento), dal succedersi delle Esposizioni di architettura razionale (1928 e 1931), delle Triennali (1933 e 1936 le più importanti, note rispettivamente come quella di Ponti e quella di Persico e Pagano) e delle celebrazioni fasciste (Decennale della Vittoria al Valentino di Torino nel 1928, Decennale della rivoluzione fascista a Roma nel 1932, Mostra dell’aeronautica nel 1934 a Milano) non esistevano schieramenti netti, teorie o idee politiche che non trovassero punti di convergenza con altri. Tutte le fazioni si contendevano con uguale tenacia il titolo di vera architettura fascista, e fu solo il concorso dell’E42 a guerra iniziata, da cui prese forma l’EUR, a sancire la definitiva vittoria – contro il razionalismo – dello stile retorico di Piacentini, tutto «archi e colonne». Pagano e Ponti, a loro volta, erano integrati nella macchina culturale fascista, anche se su fronti avversi: contrariamente alle apparenze, però, l’offensiva era condotta prevalentemente da Gio Ponti. La scelta dell’apertura e della moderazione, il ritrarsi dall’arena del dibattito ideologico non implicavano una reale tolleranza nei confronti di ricerche più radicali, e Ponti utilizzò sistematicamente tutti gli strumenti che aveva a disposizione per porre fine alla contesa sul razionalismo, ampiamente alimentata dalle idee di Pagano sull’architettura come «arte sociale». La sua politica, ovviamente lontana dallo scontro frontale, lo portò ad accogliere su domus tutti gli architetti che si allontanavano dall’eccessivo rigore moralistico di Pagano – Rogers, Lingeri, Bardi, Bottoni, Figini, Pollini, Terragni e altri confluiti poi nella rivista «Quadrante» – e lo stesso Edoardo Persico, redattore capo di Casabella, che nel 1934 diede inizio a una intensa collaborazione con Ponti. Nel 1937, dopo avere acquistato insieme a Mazzocchi Casabella, Ponti scriveva a Pagano: «la condizione che pongo alla Direzione e alla redazione di Casabella è che non si parli più di Ojetti, né direttamente né per allusione. Tu sai che come editore io intendo che Casabella sia una rivista di architettura e non di polemica né architettonica né artistica», arrivando a minacciarlo di assumere in prima persona la direzione della rivista. L’unico, forse, ad avere colto l’elemento intimidatorio celato sotto la bonaria operosità di Ponti fu Elio Vittorini, in un articolo sull’«Ambrosiano»: «A forza di Fiere dell’Artigianato e di articoli di Gio Ponti sul Corriere, il chiodo del Novecento è riuscito a penetrare in certi strati del cervello borghese (che ancor oggi purtroppo è il cervello su cui si adegua e conforma tutto il popolo italiano) e vi arrugginisce dentro. Il borghese italiano ammette, cioè, questo fatto mostruoso: un nuovo stile. Lo hanno tanto costretto a vedersi intorno queste bestie feroci, questi fenomeni quali sono per lui le forme Novecento, che ormai non può più negarne l’esistenza. Il borghese – scriveva ancora Vittorini – «riduce il Novecento alla stessa funzione convenzionale per la quale il rinascimento può dargli zampe di leone, e il rococò riboboli e dorature; cioè alla funzione del liscio e del fondo unito in quanto pura impiallacciatura di forme». Quando, nel 1948, Ponti tornò alla direzione di domus – aveva lasciato la rivista nel 1940 in seguito a un litigio con Mazzocchi – il suo spirito positivo era talmente congeniale al momento storico da fare dimenticare i direttori che lo avevano sostituito. Il periodo che aveva visto avvicendarsi o cooperare tra gli altri lo scrittore Massimo Bontempelli, lo stesso Giuseppe Pagano, Lina Bo Bardi e soprattutto Ernesto Nathan Rogers, poi passato a dirigere Casabella, da molti fu considerato, a posteriori, poco più di un intermezzo. L’Italia del dopoguerra aveva bisogno di creare occupazione più ancora di quanto non le fossero necessarie nuove abitazioni, e il piano Fanfani dell’Ina-casa rispondeva a queste esigenze dando spazio, nell’edificazione dei nuovi quartieri «per i lavoratori», alla corrente neorealista, che impiegava tecnologie e materiali tradizionali e quindi più forza lavoro. Pur mantenendo toni pacati, Ponti intraprese una lotta tenace contro questa inclinazione al vernacolo, pubblicando a più riprese l’unité d’habitation di Marsiglia, le architetture latinoamericane, le invenzioni di Mollino, le sedute stampate di Eames, le gommapiume di Zanuso, le plastiche di Kartell, e poi navi, treni, velivoli: dispiegando cioè con la massima verve tutti i progetti di area nazionale e internazionale che contemplassero l’uso di procedure tecnicamente avanzate, una produzione unificata e normalizzata degli elementi, alti tassi di sperimentazione. Confini labili tra le diverse arti. La domus degli anni Cinquanta e Sessanta divenne il manifesto di quella sinergia tra industria, imprese e professionisti che rese internazionalmente noto il design italiano, un dispositivo talmente dinamico da consentire finalmente a Ponti di mettere in sordina l’odiato dibattito teorico senza tante storie. La IX Triennale del 1951 con «La forma dell’utile» di Peressutti e Belgiojoso e nel 1954 la nascita del Compasso d’Oro (e contemporaneamente di Stile industria, sempre delle edizioni Domus, diretta da Alberto Rosselli) lanciarono i prodotti Olivetti, Arflex, Arteluce, Cassina, Altamira, i mobili di Magistretti, le lampade dei Castiglioni, i vasi di Sottsass jr. Nel giro di pochi anni nascevano Zanotta, De Padova, Poltronova, Artemide, Flos, e cominciavano ad apparire le forme arrotondate, i gonfiabili e gli ambienti fantascientifici di Joe Colombo, Ugo la Pietra, Carla Scolari, insieme ai colori del Pop e dell’Op. I confini tra arte, grafica, design, fotografia, architettura non erano mai stati così labili, e forse da nessuna parte questa indistinzione emerge con più chiarezza e maggiore fasto che sulle pagine di domus, affollate di contributi di Restany e poi di Celant, immagini di Fontana, Christo, Beuys, Calder, copertine di Munari, dello studio CNPT, di Herbert Bayer, William Klein e decine di altri artisti e designer. L’ultimo decennio di Ponti, che arriva fino al 1979, l’anno della sua morte – mostra, contemporaneamente al boom dell’architettura high-tech, il radical design fiorentino di Archizoom e Superstudio e il milanese Studio Alchimia, finendo per consegnare domus nelle mani di Alessandro Mendini. La sua versione del postmoderno, coltissima e ironica, anche se talmente anni Ottanta da risultare quasi stucchevole a uno sguardo contemporaneo, contrasta con quella più sobria offerta da Mario Bellini che si valeva della art direction di Italo Lupi: all’andamento metaforico, alla passione per la superficie del primo fa riscontro un rigore analitico e una propensione a fare bilanci a tratti autolesionista del secondo.
L’entrata nel nuovo millennio. Toccò a Lupi, grandissimo designer, dichiarare tramontata l’illusione del sorpasso dell’architettura da parte dell’industrial design: «il nostro obiettivo» – scriveva – sarà quello di mettere in relazione «il disegno dei mobili alla cultura degli interni e di riportare l’architettura degli interni all’interno dell’architettura». Vittorio Magnago Lampugnani, direttore fino al 1996, e François Burkhardt, che gli successe fino al 2000, non avrebbero avuto altra scelta se non quella di assecondare l’irresistibile ascesa degli architetti e delle loro opere sempre più spettacolari. Con l’entrata nel nuovo millennio, l’irruzione della geopolitica sulle pagine di domus costrinse l’architettura a un improvviso, anche se temporaneo, ripiegamento: il crollo delle Twin Towers di Yamasaki riuscì a scardinare una fortezza che la Seconda Guerra Mondiale non aveva neanche scalfito: per la prima volta nella sua storia, la rivista scelse una linea riflessiva, disponibile a confrontare il ruolo e le ragioni dell’architettura con la contingenza politica. Ma questa stagione non è documentata dalla edizione Taschen, che si ferma purtroppo al 2000.



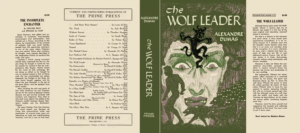


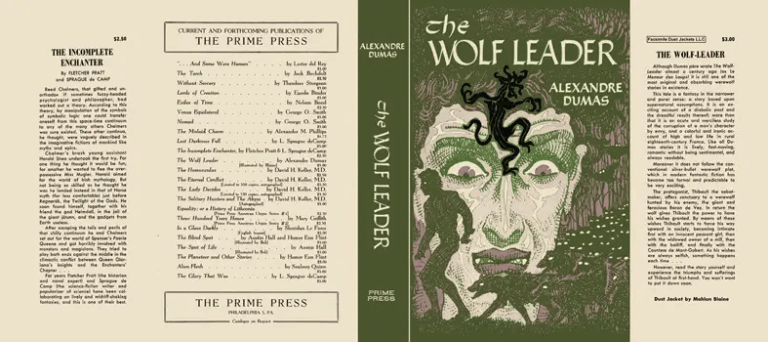


2 Comments
brianzolitudine
Posted at 13:03h, 08 Januaryleggere i tuoi post è una gran fatica, per la densità informativa ed anche oculare, ma ne vale sempre la pena. ;)
PS. Rosico di brutto, per la Cecilia.
Shelidon
Posted at 18:48h, 08 JanuarySe era un velato invito ad aumentare di uno scatto la dimensione del font dato che sto lavorando sul template… beh, è stato recepito. ;-)