Dal Manifesto di oggi, la trecensione di un libro che sembra piuttosto interessante e che so interesserà sicuramente a qualcuno… Si tratta di L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento di Patrizia Guarnieri, edito da Laterza.
Un mostro lombrosiano nell’Italia di fine Ottocento
Fra il 1873 e il 1875 nel borgo di Incisa Val d’Arno, vicino Firenze, quattro bambini scomparvero senza lasciar traccia. Un quinto, Amerigo, venne ritrovato sul punto di essere ucciso da Callisto Grandi, detto Carlino, carraio ventiquattrenne responsabile anche della morte dei quattro fanciulli spariti i cui resti giacevano nella sua bottega, sepolti sotto un palmo di terra. Seguì una rapida istruttoria, poi la confessione, le perizie mediche e il dibattimento processuale che condusse a una condanna finale di «vent’anni e più di casa di forza». Il caso, fra i primi a essere accompagnato dalla grande curiosità di un’opinione pubblica avida di particolari, è al centro di L’ammazzabambini. Legge e scienza in un processo di fine Ottocento (pp. 256, euro 15) di Patrizia Guarnieri, una ricostruzione rigorosa e coinvolgente, con un ricco apparato di fonti, che approfondisce il dibattito fra scienziati della mente e giuristi mantenendo un occhio attento alle reazioni del pubblico e in particolare dei lettori di quotidiani e giornali popolari. Il libro, uscito nell’88 per Einaudi poi tradotto nel 1992 da Polity Press, viene ora meritoriamente riedito da Laterza (pp. 256, euro 15) per l’inequivocabile attualità del tema. Carlino Grandi aveva ammesso: «tutti i ragazzi mi canzonavano, mi prendevano burla, mi dileggiavano, mi dicevano pelato, ventundito, perché in un piede ho sei diti, mi dicevano guercio e nano e quando venivano in bottega mi facevano sempre qualche birichinata e ora che ne avevo ammazzati quattro stavo meglio, e mi lasciavano in pace». La sua colpevolezza, dunque, fu da subito indiscutibile. Tuttavia questo processo rappresentò un banco di prova per le teorie del positivismo, della psichiatria e della nascente antropologia criminale, l’occasione per un confronto fra la prassi giurisprudenziale, la scienza e il senso comune ma anche fra le diverse definizioni di follia. Tanto che, a visitare il detenuto in cella, «accorsero quasi tutti i medici più sapienti di Firenze e non loro soltanto». Ma gli insulti dei bambini di Incisa ritornavano come una nenia martellante nelle parole di giornalisti, medici psichiatri, giudici e impedivano di dimenticare le difformità fisiche dell’assassino che, perennemente sullo sfondo, rappresentavano la base ideale per gli studi sui tratti somatici della malattia mentale e della predisposizione al crimine secondo le teorie divulgate in quegli anni da Lombroso. I giornali invocavano il parere degli scienziati: che misurassero il cranio, che esaminassero il corpo del colpevole dimostrando, così, come il sapere scientifico potesse e dovesse rivelare una verità sconosciuta persino al soggetto stesso. Sullo sfondo di un’Italia da poco unita e ancora impegnata nel porre le basi del suo ordinamento giuridico, la scienza e la legge giocarono, nel processo a Carlino, la loro partita. In particolare era evidente il desiderio di affermare lo status della psichiatria come disciplina e di confermare la prerogativa degli alienisti, rispetto ai semplici medici e ai magistrati, di giudicare la reale responsabilità dei comportamenti criminali. Una microstoria, dunque, capace di rimandare, in un gioco di scala, peculiarità e contraddizioni di un’epoca storica e suggerire più di un elemento destinato a durare nel discorso pubblico e in quello scientifico. Alla fine, scontata la pena, il problema di cosa fare di Grandi si ripresentò. A decidere, in base alla strampalata diagnosi di «megalomania paranoica, anestesia morale, ipocrisia, alopecia congenita», il 5 novembre 1895 fu il tribunale di Firenze che ne decretò il ricovero definitivo nel manicomio di San Salvi appena inaugurato. Eppure Carlino, pur mantenendo fino alla sua morte un comportamento quieto, questa storia «per cui lo prendevano, lo sbattevano nelle prigioni, poi lo mandavano fuori e lo chiudevano in manicomio» non riusciva proprio a spiegarsela. «Se era pazzo non dovevano metterlo in galera né tenercelo tanto; e se non lo era, come avevano detto i giudici al processo, allora dovevano lasciarlo in libertà appena espiata la pena. Non era forse logico?».


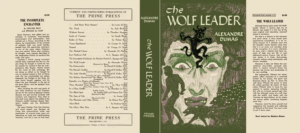


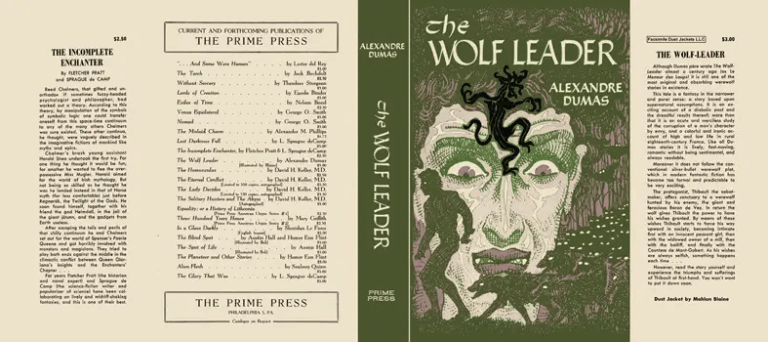


No Comments